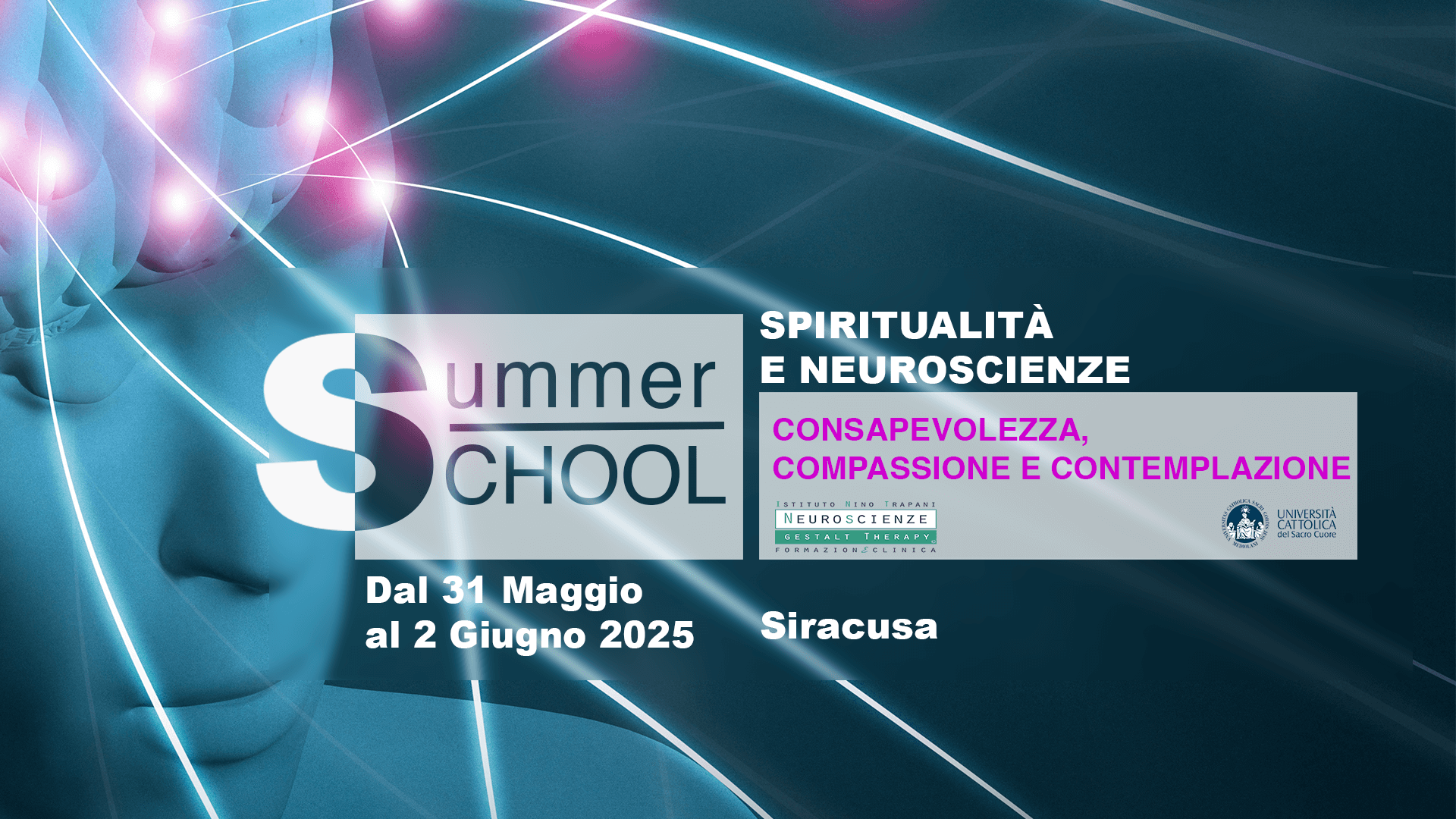Nella nostra Summer School 2023 dedicheremo, come tradizione consolidata nel tempo, uno spazio di riflessione psico-sociale gestaltico alle tragedie greche rappresentate dall’INDA al teatro greco di Siracusa, in programma questo anno: Medea di Euripide e Prometeo incatenato di Eschilo. Inizieremo con l’analisi comparativa della Medea di Euripide con quella di Christa Wolf postando ogni sabato nel nostro blog il capitolo della filosofa Angela Ales Bello, diviso in quattro parti, su “Medea fra passato e presente” scritto nel libro “Psicopatologia e tragedie greche” a cura di Paola Argentino (2005). Ecco ai nostri lettori, oggi, la prima parte:
Medea fra passato e presente di Angela Ales Bello (parte prima)
Nella luce del tramonto a Siracusa la voce di Medea risuona nel teatro greco pronunciando le immortali parole messe sulla sua bocca da Euripide: “…io sono sola, senza / patria, oltraggiata da uno sposo che /mi ha qui condotta come sua preda /da una terra straniera, e non ho meco /una madre, un fratello, un consanguineo, / presso cui rifugiarmi in così grande / sventura!”(1). Due nuclei problematici appaiono immediatamente in questa lamentazione: da un lato l’estraneità culturale di Medea rispetto alla città di Corinto, dall’altro la sventura di essere stata abbandonata, lei donna indifesa, da Giasone che l’aveva condotta in quella città; e i due momenti sono connessi perché l’abbandono è sentito come derivato dal fatto di essere straniera e di essere debole in quanto donna. Il primo problema, a mio parere di grande rilievo, è, allora, proprio quello relativo allo scontro fra culture, determinato dalla consapevolezza dei Greci di essere giunti ad un livello di civiltà altissimo e di aver lasciato dietro di loro tutti gli altri popoli, in particolare quelli che vivevano nelle terre d’Oriente. Giasone, quando si scontra direttamente con Medea, preso dall’ira, esprime questa consapevolezza in modo esplicito e brutale: “Tu non dimori adesso in una terra / barbara, come prima, ma nell’Ellade, pensaci bene, e non ignori più /giustizia e, occorrendo, sai servirti / delle leggi e ti guardi dal ricorrere /sempre alla forza. Aggiungi che la tua /sapienza è famosa in tutta l’Ellade,/ di te si parla ovunque; che se invece /fossi rimasta al tuo paese barbaro, / lontano, ai lembi estremi della terra, / nessuno al mondo ti conoscerebbe./(2). Non desidero soffermarmi, per ora, sulla capziosità del discorso di Giasone, sulla sua abilità di rovesciare a suo favore un atto di per sé riprovevole perché giudicato immorale dalla società – come è bene indicato attraverso il Coro – ma mi propongo di analizzare la questione riguardante la diversità fra le due culture, quella dalla quale deriva Medea e quella greca. Si tratta dello scontro fra un popolo il quale ha elaborato una visione del mondo che si fonda sulla potenza del logos e un popolo che nella tragedia di Euripide rimane sfumato, dai contorni non netti, ma caratterizzato da alcune connotazioni, la forza senza la legge, l’inserimento del singolo in una struttura tribale che ne impedisce la valorizzazione personale attraverso la fama, l’incapacità di condurre un ragionamento e di saperlo esporre verbalmente, lasciandosi, piuttosto, travolgere dalla passione. Non bisogna dimenticare che mentre Euripide scrive le sue tragedie, Atene sta vivendo dal punto di vista filosofico la sua stagione più felice, e non solo per la presenza di personaggi “costruttivi” come Socrate e Platone, ma per la presenza dei Sofisti, dai quali, d’altra parte, Socrate/Platone proviene e con i quali, pur distinguendosi, continua a vivere in feconda polemica. E a questo proposito ha ragione Nietzsche quando nella sua Nascita della tragedia coglie in Euripide la fine di quell’equilibrio fra apollineo e dionisiaco caratteristico delle opere di Eschilo e di Sofocle e denuncia l’appartenenza di quest’ultimo al mondo culturale basato sull’astrattezza teorica che sarà vincente in Occidente, di cui è espressione la mentalità sofistica, riscontrabile nell’abilità verbale di Giasone. Ho parlato di stagione felice non tanto relativamente ai contenuti che la retorica sofistica proponeva quanto in relazione alla forte autocoscienza critica che ormai, e direi in modo definitivo, si era affermata in Grecia e per suo tramite nella cultura occidentale. E’ quel “miracolo” che si manifesta in modo potente e prepotente nel logos occidentale: straordinaria capacità della ragione di cogliere se stessa e altro da sé, e, cogliendo se stessa, di rendersi conto anche del suo potere. Il rischio della ragione è, però, di chiudersi in se stessa disprezzando tutto ciò che non può essere razionalizzato o peggio ancora di essere strumento di realizzazione di fini egoistici che sono abilmente spacciati come universali. Si delinea, in tal modo, il doppio uso della ragione come riflessione illuminante ma anche come mezzo di elaborazione menzognera e di esaltazione dell’utile “ …Non già perché mi fosse ormai / di peso l’amor tuo, come tu pensi / nel tuo strazio inconsulto, e non perché /fossi spinto dal desiderio di una nuova sposa o di un’altra figliolanza / – mi sono sufficienti i figli che ho ,/ e non mi dolgo se non sono molti-/ ma perché mi pensavo – odimi bene;/ è questa la ragione che più importa -/ di render la famiglia nostra agiata,/ poi che gli amici subito si dileguano,/ se si cade in miseria”(3). L’abilità sofistica sta nel far apparire, per mezzo del discorso, bene ciò che bene non è; si pensi alla funzione poietica della parola in un sofista di professione quale è Gorgia, egli scrive L’elogio di Elena, ritenuta responsabile secondo il sentire comune della guerra di Troia, essendo capace di calpestare tale sentire per far trionfare l’opinione più abilmente sostenuta, la sua, appunto. Logos occidentale e ragione strumentale: la criticità ormai si è insediata in Occidente da quel tempo lontano della svolta sofistica, e quella stessa cultura che elabora il sofisma lo sa anche smascherare. La critica alla ragione strumentale è propria, nel corso del Novecento, di alcune correnti filosofiche, mi riferisco agli esponenti della scuola fenomenologica e quella sociologica di Francoforte. Con la ragione contro la ragione per far apparire ciò che è altro dalla ragione, non solo in una riflessione strutturale di tipo antropologico, ma anche interculturale: coscienza della diversità fra la cultura occidentale e le altre culture. Se questo ultimo punto è più evidente nella scuola fenomenologica – pensi ai numerosi accenni di Edmund Husserl a questa tematica nella sua ultima opera La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, nella scuola di Francoforte il logos occidentale è criticato per la sua perversione politica che dà sostegno ad un’economia di tipo capitalistico e ha come sua conseguenza la corruzione morale operata dal consumismo. Herbert Marcuse, esponente di questa scuola, diventa l’ispiratore della rivoluzione del Sessantotto che non vuole più la ragione, ma l’immaginazione al potere. Spinte estetizzanti, a loro modo esprimenti istanze morali contro l’ipocrisia della società borghese.