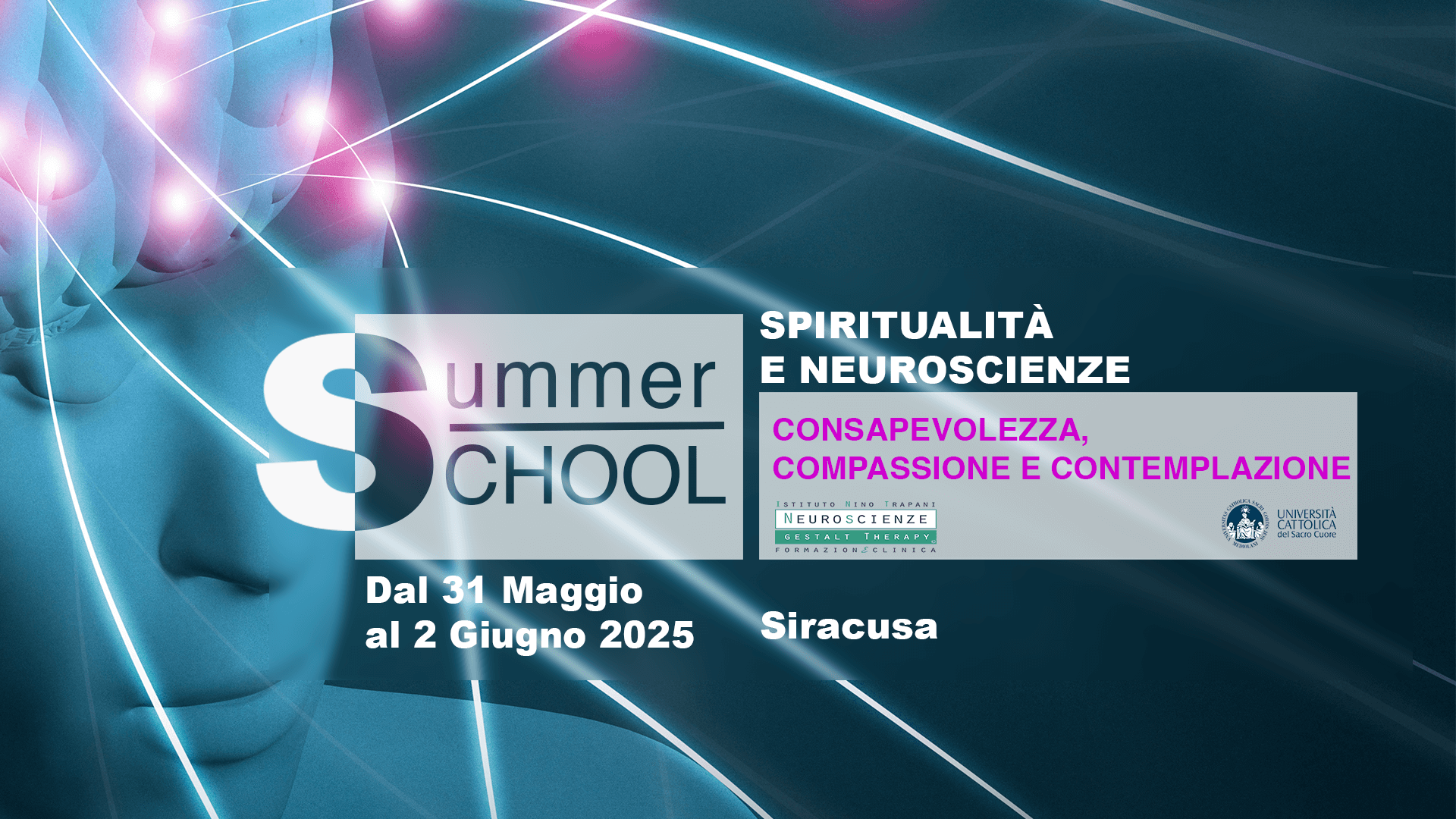L‘IRIS SELVATICO
Alla fine del mio soffrire
c’era una porta.
Sentimi bene: ciò che chiami morte
lo ricordo.
Sopra, rumori, rami di pino smossi.
Poi niente. Il sole debole
tremolava sulla superficie secca.
È terribile sopravvivere
come coscienza
sepolta sulla terra scura.
Poi finì: ciò che temi, essere
un’anima e non poter
parlare, finì a un tratto, la terra rigida
un poco curvandosi. E quel che mi parve
uccelli sfreccianti in cespugli bassi.
Tu che non ricordi
passaggio dall’altro mondo
ti dico che seppi parlare di nuovo: tutto ciò
che ritorna dall’oblio ritorna
per trovare una voce:
dal centro della mia vita venne
una grande fontana, ombre blu
profondo su acqua di mare azzurra.
È di Louise Gluck, Premio Nobel per la Letteratura nel 2020, questa poesia dal titolo “Iris Selvatico”, che dà il titolo alla stessa raccolta che la include. Una raccolta del 1992, che fece vincere il premio Pulitzer alla poetessa newyorkese per nascita, poi trasferitasi in Vermont, nel New England. Qui dunque la Gluck, ormai matura sia per esperienza di vita che per storia letteraria di pubblicazioni famose, mostra di sapersi prendere cura magistralmente del proprio giardino interiore. Riuscendo ad evitare lo stucchevole effetto di esaltare il fiore, oggetto poetico tra i più sfruttati, riesce piuttosto a creare un flusso narrativo che si snoda di poesia in poesia, intitolandola via via col nome del fiore protagonista. E l’ambiente dell’intera raccolta è proprio un immaginario, o forse reale preso a simbolo, giardino del New England dove sbocciano fiori e piante nel clima di una corta e poco calda estate , con fioriture brevi e giornate con ore di sole contato: il tutto già emblematico del tema a lei tanto caro della caducità della vita, delle contraddizioni tra eternità e fragilità, vita e morte, cura e indifferenza.
Saper cambiare, grazie a un desiderio che sempre trapela dai suoi versi, è per lei la molla più importante della vita, ma anche quello che forse sente mancarle di più; in un passo dirà: “Sentire sempre lo stesso suono di me stessa è una dannazione”. E protagonisti della raccolta, infatti, non saranno solo i fiori, ma anche la stessa poetessa giardiniera e il Grande Giardiniere-Dio, che ha con queste sue creature un rapporto distaccato, mentre lei stessa, laica e non volutamente “religiosa”, gli parla con risentimento ironico, quasi ad inserirsi nel filone ebraico (Louise è ebrea d’origine) che si interroga sul perché del silenzio di Dio sul grande male che annienta l’uomo. Così pure mai indulge a sentimentalismi, e se parla di sé lo fa con qualche cenno biografico incastonato qua e là, mentre il suo stile è asciutto con parole sempre comprensibili, e le immagini sono immediate (cespugli esplorati, terra smossa, voli d’uccelli, erbe strappate e frutti troppo maturi…) quanto allusive al mondo impalpabile del dialogo interiore. E anche questa particolare nascita dell’iris, descritta nella poesia, sa di cambiamento: intanto è “selvatico” in un giardino coltivato. Perché? Gluck non ne parla, ma avvezza a conoscere cosa sia il trauma nella propria vita, descrive il suo travaglio di nascita da bulbo sepolto a splendido fiore sbocciato in piena luce. Dalla sua biografia, poi, sappiamo che in adolescenza ha conosciuto il dramma dell’anorresia, poi curata da lunga terapia psicoanalitica, ha vissuto vissuto l’eco della morte della sorella maggiore, avvenuta prima della sua nascita, ma mai sopita nella sua storia… e via via lungo difficili vicende familiari e capovolgimenti professionali. Sconvolgimenti, cambiamenti e forse traumi, come quell’iris che trova alla fine del suo soffrire una porta: bellissima immagine per un bulbo che sfonda la terra dove riposava e ascoltava i rumori della vita allo scoperto sopra di lui. Avviene così per caso anche all’anima dell’uomo, sembra chiedersi tacitamente Louise, quando è attanagliata dal dolore di superare le proprie fatiche e vive il dramma più grande “essere un’anima e non poter parlare”? Quello che è vero per il bulbo è annunciato anche per il cuore umano quando si chiude in tombe di sofferenza e non trova parole per dirsi. Ma il bulbo infine riesce a incurvare la terra, il suo corpo tondeggiante preme sotto e fa emergere una sagoma di rigoglio, e mentre lo fa, coglie un palpito di vita soprastante che non immaginava. Superbo qui il verso: “E quel che mi parve uccelli sfreccianti in cespugli bassi”. C’è un gioco di direttrici in un’anima che si schiude alla rinascita dopo tanto silenzio e sofferenza, dopo tanta macerazione nascosta. Come a chiedersi: quando le parole riemergono come rigonfiamenti nella terra rigida, cosa si coglie dell’altro, quel fuori che qui è rappresentato da uccelli che volano veloci ma su cespugli bassi, giochi antitetici di parole altrui che cominciano a capire? Sa “sfrecciare” il nuovo contatto avvenuto sopra il sé affiorato, ma ancor di più cosa avviene in quel silenzio basso e abitato di un cespuglio nascosto di intimità nuova? E qui Louise, la ragazzina e la donna che ha sofferto, si dichiara apertamente sotto la metafora del bulbo dischiuso: “seppi parlare di nuovo”, perché quando si esce dall’oblio della propria solitudine si ritrova la voce. Superba la chiusa, solo in apparenza descrizione botanica del fiore iris: la grande fontana azzurra, fatta di ombre blu su azzurro acqua è icona più grande di un’acqua di vita che zampilla nuova dentro un mare ampio.
Chiara Gatti