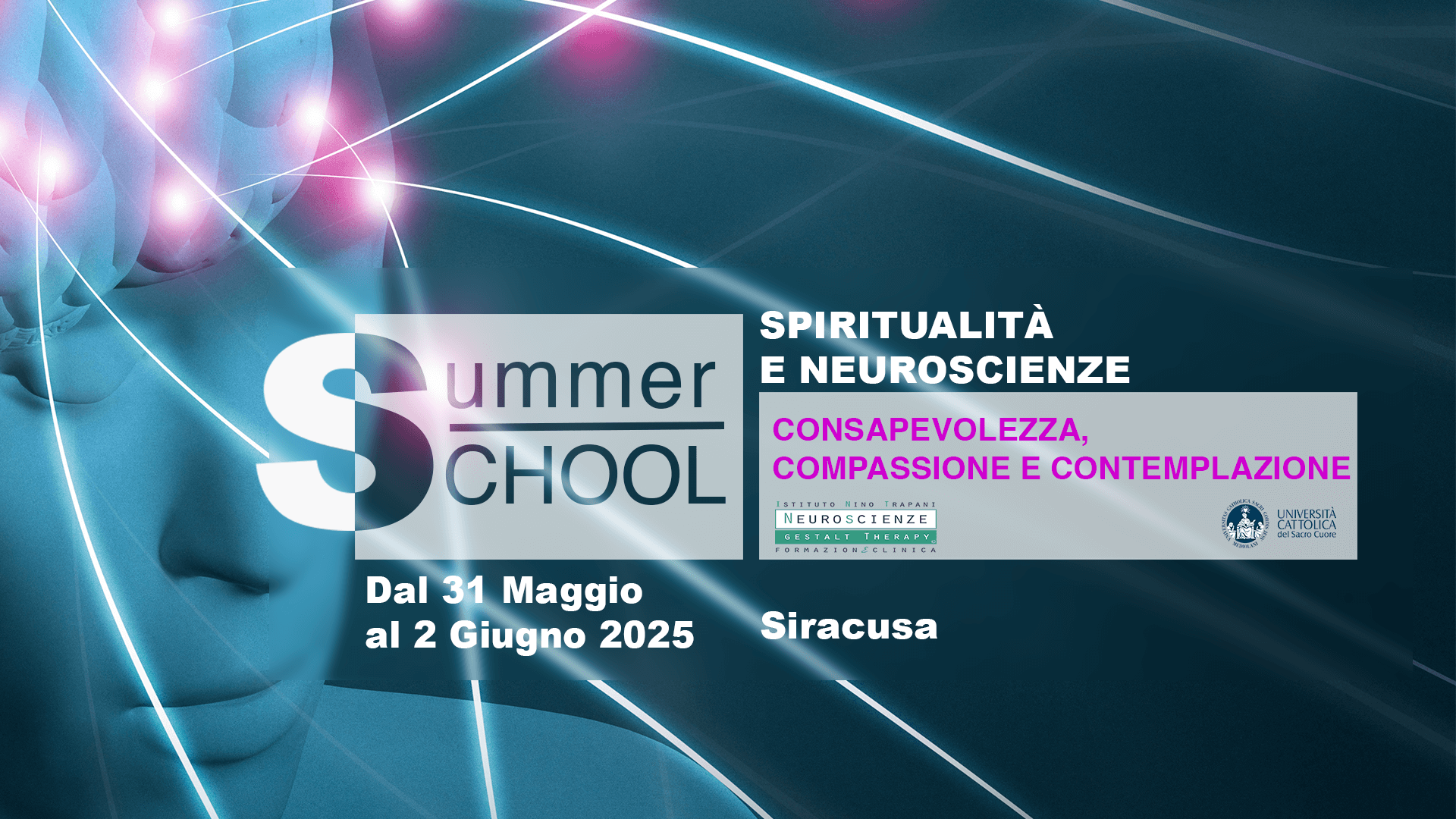Lucia in terapia piange lacrime copiose, appena entrata nell’ambulatorio medico. Accolgo questo suo linguaggio che scuote il mio corpo, sotto il camice bianco, e arriva dritto al cuore, e in atteggiamento di sincero ascolto empatico le chiedo, con delicatezza, cosa l’addolora. La risposta è un intensificarsi del pianto che diventa più accorato ed accompagnato da un ripiegarsi su se stessa, quasi in posizione fetale. Mi avvicino e le porgo un fazzolettino che Lucia prende, ma non usa per asciugarsi le lacrime, lo stringe forte tra le mani però e lo guarda. I suoi occhi non sono più strizzati unicamente nel viso, a tratti li apre per quel fazzoletto. Conosco parte dei suoi vissuti strazianti di cui nel tempo mi ha reso partecipe, e vorrei aiutarla a placare le sue angosce che la fanno piangere senza sosta… allora, in quel momento, scelgo la via più sicura, meno coinvolgente personalmente, e certamente scientificamente efficace e le dico: “Oggi stai proprio male Lucia, ti prescrivo una compressa da prendere dopo colazione, per aiutarti in questa sofferenza”.
Lucia per un attimo alza gli occhi verso di me e mi chiede cosa può fare questa pillola per farla stare meglio, le rispondo che è un antidepressivo. “Un anti…che? “– mi chiede spaventata.
Non ha potuto studiare per la povertà socio-culturale della sua famiglia di origine, e capisco che ho utilizzato un termine tecnico a lei incomprensibile. Allora cerco di spiegare cosa è un antidepressivo con un linguaggio più semplice, di questo tipo: “Si tratta di una medicina che ti darà più coraggio ad affrontare i problemi della vita, ti aiuterà ad avere un umore più positivo, insomma a non piangere così tante lacrime”. La reazione di Lucia a questo mio tentativo di spiegazione mi coglie di sorpresa. Ricomincia a piangere, più forte di prima, addirittura a singulti, con tutto il suo corpicino esile e smagrito che trema di paura e tra una lacrima e l’altra mi implora: “No, dottoressa no, no, no, la prego non mi tolga le mie lacrime, cosa faccio poi se non posso neanche piangere? Io voglio le mie lacrime, mi fanno compagnia, mi fanno uscire il dolore che sento dentro di me, non voglio una medicina che mi toglie le lacrime…”
Cambio registro allora, abbandono la strada farmacologica e accolgo le sue lacrime come richiesta primaria di relazione affettiva. Stavolta mi avvicino con un fazzoletto di nuovo, ma non glielo porgo come prima, direttamente e delicatamente tento di asciugarle le lacrime che abbondanti le inondano il viso. Lei mi guarda con occhi sofferenti e luminosi e sussurrando mi confida un suo segreto: “Lo sa dottoressa perché io non mi asciugo mai le lacrime? Perché sono calde e il mio corpo è freddo e quando piango dove passano le lacrime mi sento riscaldata”.
“Scusami Lucia – le rispondo – ho sbagliato di nuovo, prima a proporti la medicina ed ora ad asciugarti le lacrime”.
Accade allora quello che a me è sembrato un dono stupendo ed inaspettato della relazione di cura.
Lucia accenna un sorriso, e mi dice: “No dottoressa, non ha sbagliato ad asciugarmi le lacrime perché mi sono emozionata tutta, mi sento voluta bene e capita da lei, non voglio le medicine, vorrei poter venire a piangere da lei ogni tanto”.
Sorrido anche io e la rassicuro che può venire quando vuole in terapia da me per piangere, ma anche per ridere, perché la vita, per fortuna, offre un arcobaleno di emozioni.
IL DONO DELLE LACRIME
La lacrime sono un dono di inestimabile valore perché in grado di esprimere emozioni profonde e devastanti anche quando il dolore ha consunto tutte le parole. Esse creano un linguaggio nuovo, una comunicazione alternativa alle parole, che pur nel silenzio è densa di suoni arcaici: la voce dell’anima. Quando il ‘non detto’ riesce ad emergere dalle cicatrici del cuore nel pianto liberatore, le lacrime diventano strumento di condivisione e richiamo intimo alla relazione affettiva. Così canta la poetessa:
E beati voi /che avete il dono delle sante lacrime, / e se anche le trovate ingiuste / agli occhi di Dio / appariranno rugiada / che farà crescere rose / nella vostra carne.
ALDA MERINI (in Mistica d’amore, Cantico dei Vangeli, pp. 293–294)
PATHOS e PENTHOS
L’afflizione, in greco “penthos” ha la stessa radice etimologica di “pathos”, il dolore psichico: derivano entrambi dal verbo “pathein” che significa ‘soffrire’. Esiste una connessione tra le lacrime ed il penthos, dirà Simeone che la sofferenza trasforma l’anima in una fonte di lacrime.
Ma ancora più stretta è la interconnessione tra le lacrime e l’amore, come afferma Gregorio di Nissa che è la passione (pathos) per Dio a suscitare le lacrime (penthos) e viceversa le lacrime sono causate dalla privazione di qualcosa di desiderabile, di amabile.
Le lacrime e l’amore, sono le due facce di una stessa medaglia che è la vita e rigenerano continuamente le relazioni tra gli uomini e con la divinità. I padri del deserto infatti chiamavano penthos, il dolore interiore che apre ad una rinnovata relazione con il Signore e con il prossimo.
Oggi ricorre l’anniversario della lacrimazione della Madonna a Siracusa, la mia città natale.
Esiste una letteratura fiorente sulla teologia delle lacrime, su cui non mi soffermo, mi piace pensare a Maria, la Madre di Dio e di tutti noi, che si manifesta al mondo con le lacrime da un quadretto posto come capezzale del letto di una donna con gravidanza complicata.
Le lacrime di Maria, segno di afflizione, scelgono un contesto di sofferenza che genera vita: la gravidanza! E d’altronde la prima esperienza umana del pianto è proprio alla nascita il primo vagito, quelle lacrime che segnano il passaggio tra l’essere e il divenire nell’alba della vita.
Paola Argentino