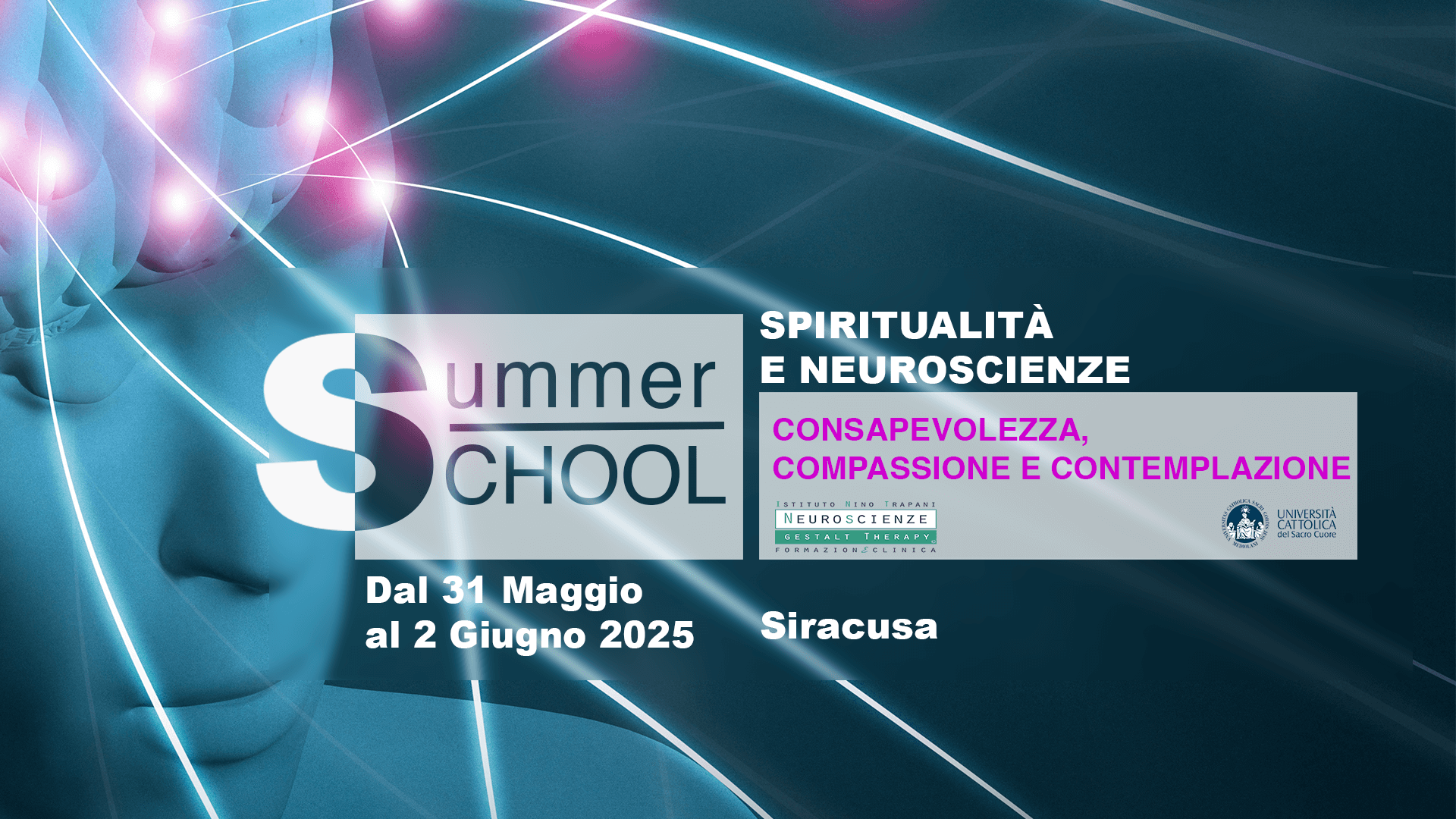Alcune note di analisi biblica che ho dovuto riprendere in mano in questi giorni, per motivi di insegnamento, mi hanno stuzzicato un collegamento col tema delle maschere e dei volti, attraverso l’infinita questione antropologica della ricerca dell’identità. Parlo della cosidetta “storia dei nomi di Dio” nel mondo ebraico, che mi ha prodotto una domanda proprio a cavallo tra la bibbia e identità: i nomi di Dio nell’antico testamento sono maschere o volti?
JHWH (leggi Jawè, più o meno) ed Elohim, sono i due nomi classici di Dio, maggiormente presenti nella bibbia ebraica. Ma in realtà il panorama dei suoi nomi è più largo. E forse, è possibile descrivere una vera e propria traiettoria storica di come gli Ebrei si sono posti di fronte ai nomi di Dio.
Dalle origini politeiste dei popoli confinanti con Israele, gli ebrei hanno sicuramente tratto l’uso di due nomi. Il primo è Shadday (o El Shadday) usato solo sette volte nella bibbia e solo nell’iniziale epoca dei patriarchi ebraici, che si può tradurre con “Il Dio della steppa che violenta, distrugge e saccheggia”. Assieme a questo, Israele assorbe anche l’uso di Elohim (o Eloha al singolare, forse imparentato con Allah) che ha il suo etimo nell’espressione “la forza di colui che ti sta di fronte, cioè dell’alterità”. Questo nome, fin dall’inizio viene assolutamente preferito dagli Ebrei a Shadday, tanto che è presente nell’antico testamento 2361 volte, nelle varie combinazioni grammaticali. Questa scelta smaschera un primissimo volto della divinità: una alterità potente, che si impone, ma non distrugge; comanda, ma non uccide.
Elohim è un plurale e gli Ebrei, agli inizi della loro storia, non sono monoteisti in senso stretto, ma monolatrici. Ammettono, cioè, l’esistenza di più dei, ma loro hanno scelto di adorarne uno solo, il Dio (Elohe, al singolare) di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E quando questo Dio rivela loro il suo nome, un altro suo volto tende a smascherarsi: JHWH è derivazione, dalla terza persona singolare, dell’imperfetto del verbo essere, e indica una azione senza tempo, presente dal passato al futuro. Perciò andrebbe tradotto con “colui che era, che è e che sarà”.
Non c’è dubbio che questo nome finisce per sopravanzare di molto Elohim, nella teologia ebraica, fino ad essere presente nell’Antico Testamento ben 6830 volte. Come a dire che quella “forza dell’alterità”, lentamente, porta allo svelamento di un altro lato dell’identità della divinità, che si rende percepibile come stabilità del suo essere nel tempo, fedeltà radicale a sé stesso, sempre e ovunque.
Ed è proprio la percezione di questa stabilità costante nella storia degli Ebrei a permettere loro di raggiungere, dopo circa 800 anni dalle loro origini, un vero monoteismo: JHWH ha compiuto, e continua a compiere, cose enormi per loro, prodigi inimmaginabili, guidandoli con fedeltà al loro bene; gli altri dei non esistono, perché non compiono nulla di bene, per i popoli che a loro si riferiscono.
Ma una terribile esperienza del popolo ebraico cambia le carte in tavola. Il doppio esodo, prima ad opera degli Assiri e poi dei Babilonesi, interrompe parzialmente la trasmissione generazionale della lingua ebraica e, dopo l’esilio, i Masoreti (esperti biblici del tempo) sono costretti a inserire anche le vocali nella scrittura ebraica per consentirne la lettura, fino ad allora solo consonantica. Stranamente, però, nel nome di YHWH vengono inserite le vocali del termine Adonai, in modo che, da allora, YHWH non sarà più pronunciato verbalmente, ma al suo posto si pronuncerà il nome Adonai.
Questo nuovo nome di Dio significa letteralmente “mio signore” e, assieme al divieto di pronunciare YHWH (tranne nelle liturgie di alcune feste solenni), ci indicano come, ancora una volta, l’identità di Dio mostri, sotto le maschere dei nomi precedenti, altri due volti. Da un lato che la stabilità fedele dell’essere di Dio, produce effetti amorevoli se gli Ebrei riconoscono e si attengono alla Sua signoria sulla loro vita. Dall’altro che, forse, ormai è impensabile che un solo nome possa racchiudere tanta varietà e ricchezza divina, e che per essere meno infedeli a ciò, è bene appellare Dio solo con la funzione che egli svolge per gli Ebrei (Signore) e non più tentando di racchiudere la sua essenza in una sola parola.
Ma le cose non finisco qui. Per darsi ragione del dramma accaduto, il post esilio è un periodo di grande riflessione sapienziale e profetica. Fino alla comparsa di un altro nome di Dio, anche se poco presente nei testi, ma molto nella riflessione teologica: Abbà, che significa papà, indicando una paternità con una connotazione molto tenera e dolce. Il libro del Siracide e il Salmo 103 portano a maturazione le tracce precedenti di Osea, Deuteronomio e Isaia, in cui la signoria di Dio inizia a mostrarsi come paternità amorevole. E qui si innesterà l’uso dell’ebreo Gesù di rapportarsi con Dio chiamandolo Abbà. Termine che trova l’etimo nell’espressione “fonte di vita”. Ancora uno smascheramento: quel Dio indicibile e signore in realtà è un padre amorevole che si consegna totalmente per il bene dei figli.
Al termine di questo veloce racconto, allora, possiamo fare un tentativo ardito, ma sensato. Il percorso evolutivo ebraico, alla ricerca dell’identità di Dio, espresso nelle trame della “storia dei nomi di Dio”, può essere preso come paradigma sano della ricerca della nostra identità personale. Come per gli Ebrei, la cui storia è un susseguirsi di passi in cui si lasciano cadere, ai lati del sentiero, successive maschere di Dio che non “parlano” più sufficientemente di Lui, così l’essere umano procede ad una “spogliazione” progressiva di una serie secessiva di maschere, ognuna delle quali dice qualcosa di noi, ma al tempo stesso limita noi stessi solo ad un aspetto, che non sembra più sufficiente a raccontare ciò che siamo nel qui e ora, rispetto al nostro passato.
Nel confronto con la “forza dell’altro”, io scopro una mia identità più profonda e stabile, che resta “fedele a sé stessa”, ma si rivela essere “non pienamente conoscibile ed esprimibile”. La sua percezione, però, è sufficiente perché tale essere si affacci alla mia coscienza come “signoria sulla mia vita”, cioè come un dato che mi precede e che mi è indisponibile. Se lo accetto e lo riconosco in questa sua “alterità” che mi fonda e mi definisce, tale rapporto di signoria tende a diventare una “relazione di figliolanza”, in cui, ben lungi dal presentarsi come signore potente e limitante, la mia identità finisce per rivelarsi la “fonte della mia vita”.
Ma l’analisi di questa “storia dei nomi di Dio” sembra suggerire anche una seconda conseguenza: la possibilità di percepire un’identità di sé più piena e più stabile, ci sarà solo quando l’uomo accetterà di andare oltre sé stesso. Cioè quando accetterà di lasciare che i nomi dell’altro e i nomi con cui l’altro ci chiama, possano contaminare i nostri nomi, accettando il rischio di perdere la propria identità, ma per arricchirla e allargarla dentro un “noi” che non lo uccide, ma lo realizza pienamente.
Gilberto Borghi
Docente di Teologia, Pedagogista clinico.
Didatta del Master in Pastoral Counselling