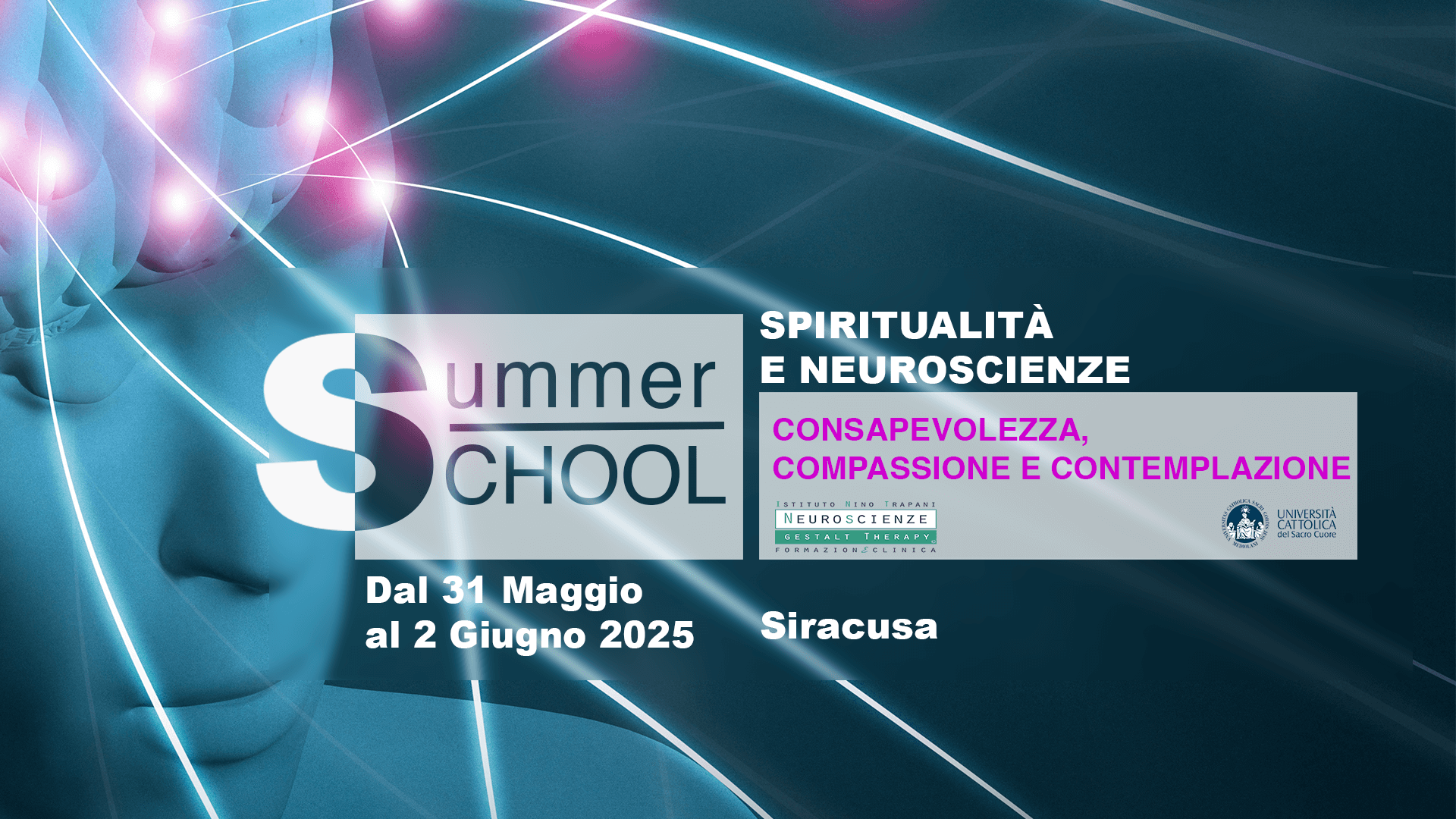Esattamente due settimane fa, il 4 dicembre, ci ha lasciato all’età di 94 anni un grande uomo del panorama medico-scientifico e culturale, lo psichiatra Eugenio Borgna, la cui biografia risplende nella sua lunghezza per la continua perseveranza nel propagare in Italia le intuizioni di Franco Basaglia e di una nuova psichiatria, affrontando la cura del paziente psichiatrico basandosi sulla relazione profonda e non più sui metodi di contenzione e le tecniche invasive di cura precedentemente usate. In questi giorni di lui hanno parlato in tanti, con competenze e cognizione di causa ben maggiori della mia: io posso solo limitarmi alla conoscenza di alcuni suoi scritti e suoi interventi e relazioni per suggerire qualche imput dei messaggi attualissimi che quest’uomo ci lascia.
In primis quell’attenzione alla persona del paziente, e alla relazione con lui, che lo ha portato in un’ottica fenomenologica a incarnare una “psichiatria dell’interiorità”, con luminosa definizione del suo modo di essere e operare. E qui si apre il grande capitolo di cosa fosse per Borgna l’interiorità: figlio del verso agostiniano, da lui tante volte citato,” in interiore homine habitat veritas”, egli si avventurava nei luoghi della conoscenza profonda di sé che riteneva spettasse ad ogni uomo, non semplicemente al medico psichiatra che si trovava di fronte la mente sconvolta altrui e per questo doveva conoscere un po’ meglio la propria. Nelle ‘Premesse’ di “Apro l’anima e gli occhi. Coscienza interiore e comunicazione”, un suo libro del 2021, ispirato come titolo a una bellissima poesia di Clemente Rebora, egli si domanda: “ci conosciamo, meditiamo, sappiamo isolarci dalle nostre impressioni immediate, dedichiamo tempo e pazienza indispensabili a conoscere le sorgenti profonde, e non solo quelle superficiali, dei nostri gesti e delle nostre azioni, delle nostre emozioni e dei nostri pensieri?”. E la sua domanda non era auto centrata solo su un benessere derivante da questa attitudine, ma finalizzata alla possibilità di “dare un senso alla nostra vita e conoscere quello di cui gli altri hanno bisogno, e che non hanno magari il coraggio di chiedere”. Tutti fratelli, dunque, nel bisogno di conoscere se stessi e soccorrersi vicendevolmente, ciascuno nel proprio ruolo.
E inoltre l’importanza di una comunicazione vera, che nutriva la relazione soprattutto col paziente psichiatrico, in un gioco tra verbale e non verbale, dove le parole, da lui definite “creature viventi” per la loro importanza, si mischiavano “col linguaggio del silenzio e della solitudine, degli occhi e degli sguardi, delle lacrime e del sorriso”. Emerge qui la sua concezione di silenzio, sentito come “elemento che cura e ristora”, per primo noi stessi e poi gli altri, quando si lascia loro un letto caldo e accogliente di ascolto col proprio tacere attento e proteso. Egli stesso, poi, coltivava quegli spazi di solitudine e silenzio, come racconta in un altro suo libro del 2024 “In ascolto del silenzio”, essendo un assiduo frequentatore del monastero di San San Giulio, sul lago d’Orta dove si recava in solitudine a leggere e a scrivere, come lui stesso riportava in un’intervista.
Così in questo libro analizza come tale dimensione possa appartenere certamente, in quanto sofferenza, ad alcune forme di patologia psichiatrica, ma anche alla realtà della vita di ogni persona perché silenzio e parola sono due tempi unici che necessariamente si intervallano. In altra intervista, ad esempio, raccontava anche delle sue lunghe attese davanti alle lallazioni incomprensibili di qualche ammalato psichico grave, e dell’ attesa silenziosa che gli permetteva a volte di cogliere un brandello di senso, dove sgorgasse una parola per aprire un varco di comprensione e aiuto.
Infine ci piace immaginarlo, Eugenio Borgna, in un numero non più annoverabile di colloqui con pazienti, con quella delicatezza e quel rispetto pieno dell’altro che lo caratterizzavano… In contatto con le tante pazienti donne, che ha curato come direttore del reparto femminile dell’Ospedale psichiatrico di Novara, permettendo loro di non essere più recluse, ma libere di circolare anche nel giardino, senza più inferriate alle finestre, dove la relazione e l’ascolto empatico non erano meno importanti delle cure farmacologiche.
Così se, lontano da quei giardini, proviamo a ricordare i versi di un’altra sfortunata paziente psichiatrica, Alda Merini, geograficamente non molto distante da Novara, ci commuove sentire che “il manicomio è una grande cassa di risonanza/ e il delirio diventa eco,/l’anonimità misura, /il manicomio è il monte Sinai,/maledetto, su cui tu ricevi le tavole di una legge/agli uomini sconosciuta”. E ora, alla luce di quanto detto, con l’umiltà che occorre quando ci avviciniamo all’enorme sofferenza di chi ha dovuto patire l’eco del proprio delirio, proprio perché non c’è stato chi abbia saputo accoglierlo come delicata cassa di risonanza, un grazie ancora maggiore sale a questo uomo! A lui, che di quel Sinai si è fatto paziente ascoltatore, non riscrivendo presuntuose leggi nuove, ma tentando di apprendere quel linguaggio sconosciuto alla maggior parte degli uomini, che non è la follia, ma la possibilità di starle accanto con profonda compassione e speranza, in una resurrezione dove nessuno è più “anonimo”.
Autrice: CHIARA GATTI, counsellor professionista e docente del Master in Pastoral Counselling dell’Istituto Nino Trapani (articolo già pubblicato nel sito www.vinonuovo.it).
In memoria di Eugenio Borgna, lo psichiatra dell’interiorità.