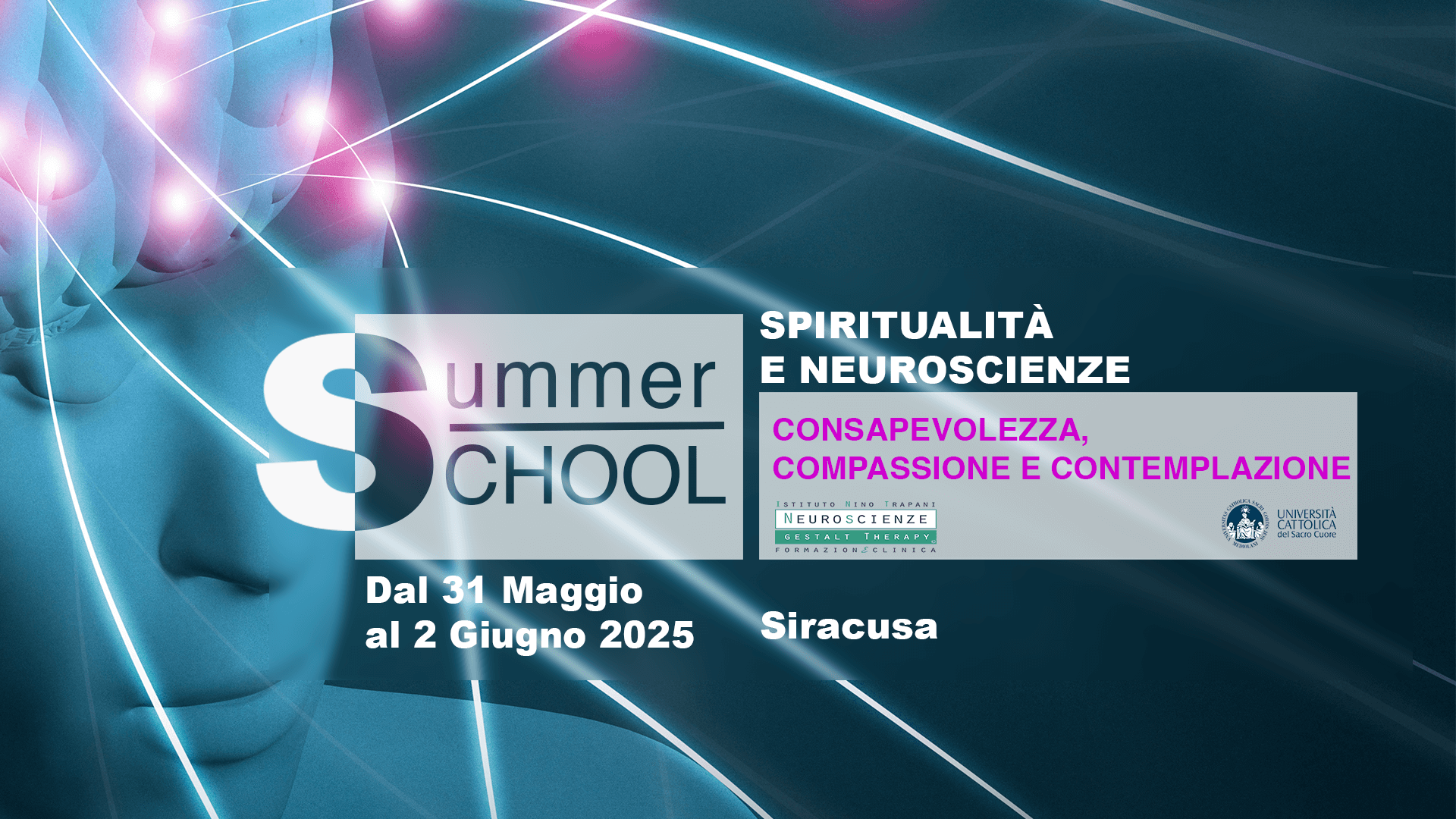“Padre…. Stringo alle tue ginocchia, come un supplice ramo di olivo, il mio corpo, il corpo che lei ha generato per te. Non mandarmi a morire, così giovane: è bella la luce del sole, non costringermi a scendere nel mondo delle tenebre. Per prima ti ho chiamato padre e tu mi hai chiamato figlia, per prima, arrampicata sulle tue ginocchia, ti ho fatto tenere carezze e tu me le hai contraccambiate. E mi parlavi così: «Ti vedrò vivere felice, figlia mia, e fiorire in modo degno di me nella casa del tuo sposo?». Io, avvinghiata al tuo collo che ora sfioro con le mani, replicavo: «Cosa farò io per te? Ti accoglierò vecchio nella mia casa come caro ospite, in cambio della fatica che ti sei dato per allevarmi?». Io mi ricordo dei tuoi discorsi, ma tu li hai dimenticati e vuoi uccidermi”. (Ifigenia in Aulide, vv.1220-1232)
È il corpo il protagonista delle parole che questa figlia rivolge al padre, metaforicamente indicato col ramo di ulivo che reggevano i supplici nel rito, ma anche un corpo come virgulto giovanissimo che si avvinghia ad una figura adulta per crescere. Corpo di padre presente nelle ginocchia, su cui lei piccolina gioca serena, nelle tenere carezze reciproche (si noti come qui il termine carezze sia lo stesso che traduce più ampiamente grazia, bellezza, beneficio, amorevolezza…), anticamere di amorevoli promesse. Il padre si augurava, con uno stilema fisso, di vederla un domani sposa felice in un luogo degno del suo casato, e lei come figlia “che per prima lo aveva chiamato padre”, in quanto primogenita, assicurava il doveroso onore di prendersi cura del proprio genitore in vecchiaia. E se allora le manine della bimba si aggrappavano al collo del padre, come non essere consapevoli che Ifigenia anche ora sa sfiorare il suo collo, col gesto di implorazione dei condannati? Eppure quel momento di amore vissuto nell’infanzia per lei è stato vero e fondante, per essere poi quella vergine, pronta alle nozze, che era arrivata felice in Aulide.
È forse in quell’amore, compreso bene in un contatto pieno sulle ginocchia del padre, tra manine che giocano con un collo robusto e ginocchia come sgabello sicuro, è in quel luogo che Ifigenia aveva imparato che lei stessa poteva far dono di sé autosacrificandosi? Sappiamo che Ifigenia non sarà capace solo di questo, ma la sua è, anche dopo, la storia di una donna forte e salda nella sua identità, quando, portata in Tauride da Artemide stessa, dovrà occuparsi di cruenti sacrifici e sarà in grado di evitare, grazie al riconoscimento del fratello Oreste, che anche lui venga ucciso come vittima alla dea. Esperta di sacrificio, dunque, Ifigenia!
Mi piace pensarla, ora, come colei che porta quello che ha saputo costruire in sé, calandolo in una vita piena, per offrire il compimento del proprio dono: un’ infanzia luminosa, gioco sicuro e chiaro di un amore fondativo, luce perenne nei meandri confusi di una vita.
Chiara Gatti