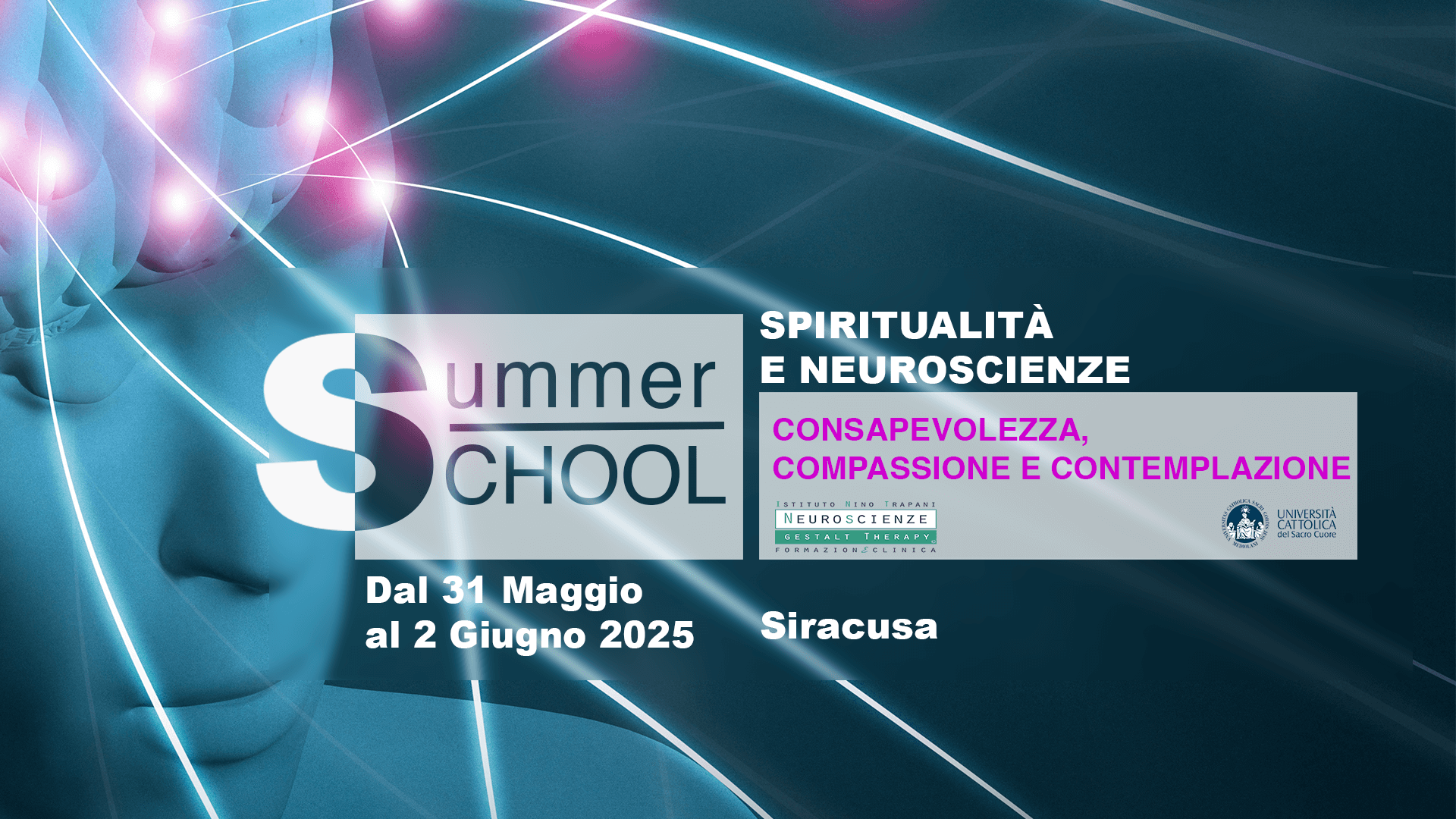Nell’intreccio tra nome e volto, tra Maria e Cristo, tra presenza e liturgia, la parola chiave è «singolarità». Una parola inquietante rispetto alla quale le società umane hanno reagito costruendo teorie e prassi. La singolarità è stata inserita in classi di appartenenza e in percorsi capaci di organizzarla. Le classificazioni e le organizzazioni riconducono l’identità del singolo a quanto ha di identico con un altro singolo: ciò che conta non è tanto l’identità del singolo quanto l’identità della classe e dell’organico in cui raccogliere molteplici singoli. Nonostante questi sforzi tassonomici, però, la singolarità ha lasciato sempre traccia di sé e della propria radicale irriducibilità. L’identità del singolo è irriducibile perché è la differenza dall’identità di un qualsiasi altro singolo. Il problema dell’identità e della differenza, del singolo e dell’universale, è al centro di innumerevoli trattati di logica, ma anche di tante elaborazione filosofiche e scientifiche. Il pregiudizio che spesso si riscontra in queste elaborazioni è la convinzione che la costruzione di un universo di senso implichi l’assorbimento della differenza specifica del singolo in un quadro omologante. Non è questa la strada obbligata come può emergere da un’attenta fenomenologia del «nome» e del «volto»; non è la strada delle religioni che collocano il sacro in stretta sintonia con la singolarità di eventi irriducibili e che nei loro percorsi mitico-rituali danno spesso rilevanza al nome e al volto; non è la strada della fede cristiana e della sua liturgia che implicano la singolarità di Gesù e la sua presenza lungo la storia anche attraverso la parola che si fa nome e l’immagine che si fa volto. All’interno di questa prospettiva, il riferimento mariologico è legittimato dal fatto che Maria è una figura che sottolinea la singolarità e la presenza di Cristo. Il contesto in cui viene a piena maturazione questo intreccio tra nome e volto, tra presenza di Cristo e Maria, è quello liturgico, a motivo delle sue qualità simbolico-rituali. Occorre, allora,: a) verificare la rilevanza della singolarità per la fede cristiana; b) indagare il nome e il volto come forme della singolarità e di apertura al sacro; c) mostrare come la liturgia sia il luogo nel quale il nome e il volto sono pienamente presenza di Cristo.
1. LA PRESENZA DI CRISTO COME PRIMATO DELLA SINGOLARITÀ.
La considerazione di fondo è che vi è uno scarto radicale tra la classificazione delle cose e il fondamento che ne costituisce il senso. Le religioni per lo più riferiscono di un’origine che splende per la sua singolarità, ed è interessante che la stessa fisica teorica recepisce la singolarità come evento originario dell’universo. D’altra parte le religioni e ancor più la fisica si sono sempre impegnate, a loro modo, in un processo di classificazione grazie al quale contestualizzare i singoli fenomeni e comprenderli. Cosa avviene nella nostra mente quando accostiamo questi due procedimenti, uno che va verso la singolarità, l’altro verso la contestualità? Il sacro, forse, ha a che fare col corto circuito provocato da tale accostamento che indubbiamente è rilevabile anche nella fede cristiana.
1.1. Il sacro e la singolarità.
«Tutte le credenze religiose, semplici o complesse, a noi note – scriveva E. Durkheim – presentano una caratteristica comune: suppongono la sistemazione delle cose, reali o irreali, in due generi opposti, resi abbastanza bene dai termini profano e sacro» . Nella visione durkheimiana la classificazione profano-sacro deve essere a sua volta intesa alla luce della classificazione individuale-collettivo , con la conseguenza che il contesto sociale è decisivo per il fenomeno religioso. L’essere umano però incrocia costantemente il contesto sociale con quello ambientale e in entrambi sperimenta pericoli che deve evitare. Un caso tipico è quello di origine igenica che implica il rapporto con le cose e le persone secondo la classificazione di puro e impuro. M. Douglas, mettendo in evidenza lo stretto legame tra sacro-profano e puro-impuro, ha sottolineato che sebbene le religioni talvolta considerano sacre cose impure, non fanno assolutamente coincidere il sacro con l’impuro . Riferendosi alla teoria di Durkheim e inserendovi la questione del rapporto puro-impuro, J. Cazeneuve osserva che, a ben vedere, «il sacro deve essere di natura sintetica e proprio per questo distinguersi dall’impurità […]. L’esame critico della teoria di Durkheim – continua Cazeneuve – sembra in definitiva condurre alla seguente conclusione: il sacro ha da essere un principio sintetico, un principio che trascende l’opposizione del puro e dell’impuro […]. La sintesi non può essere realizzata che per mezzo di simboli in grado di rappresentare l’ordine della condizione umana e, nello stesso tempo, di possedere la potenza di ciò che sfugge a quest’ordine, di ciò che non è condizionato. Questi simboli devono garantire le regole dell’universo umano e tuttavia possedere la forma e la struttura di quanto è extraumano. Il sacro partecipa quindi di ciò che è regolare e di ciò che è eccezionale» .
La conclusione di Cazeneuve è quanto mai rilevante perché, riconoscendo nel sacro la compresenza del regolare e dell’eccezionale, pone il sacro stesso al di là di ogni classificazione o categorizzazione. Le religioni operano su una base, su un’origine che ha un’insuperabile ambiguità di fondo. Anche la doppia valenza attribuita da R. Girard alla vittima espiatoria esibisce questa ambiguità del sacro. In questo caso è il rito (il sacrificio) che consente il passaggio dalla vittima come colpevole alla vittima come salvatrice. Il sacro emerge da questo passaggio giocato sulla singolarità della vittima espiatoria . Ma la questione decisiva riguarda la compresenza del regolare e dell’eccezionale che si configura anche come incrocio tra ciò che è classificabile e ciò che mantiene un margine di singolarità irriducibile a qualsiasi classe. Nella storia delle religioni lo scarto tra l’ordine di un contesto regolato e il disordine di una singolarità irriducibile emerge innumerevoli volte. Quello scarto è l’esperienza del sacro come esperienza del sorprendente, ossia l’esperienza di un evento la cui singolarità rompe l’ordine costituito.
Le esigenze dell’ordine, indubbiamente non possono essere trascurate, soprattutto quando consistono nella possibilità di ricondurre la singolarità entro un contesto di cui siano riconoscibili le caratteristiche e le regole. Occorre, però, riconsiderare il rapporto tra il contesto e la singolarità, tenendo presente che essi si incrociano e, a seconda delle prospettive, si scambiano i ruoli. Se la singolarità, qualsiasi singolarità, prende senso dal contesto di appartenenza e dal sistema teorico entro cui si colloca, nel caso di tante credenze religiose, si nota un parziale capovolgimento, dato che è la singolarità a dare senso al contesto di appartenenza e a legittimare il sistema teorico . Si tratta di un capovolgimento parziale, perché rimane vero sempre anche il fatto che la singolarità non può prescindere dal contesto. Ciò che è importante, però, è che nessun contesto può assorbire completamente la singolarità. Questa, infatti, implica quel valore di eccezione, quell’uscita dallo stabilito, quella rottura del quadro predeterminato, che è alla base della trascendenza e quindi del sacro. Ovviamente, è compito di ogni religione di armonizzare l’eccezionale tipico della singolarità col sistema di riferimento di una società e dei suoi valori. Rimane il fatto, però, che non vi potrebbe essere alcuna nozione di trascendenza senza l’esperienza di qualcosa di esuberante e di incontenibile rispetto a un contesto concluso. La singolarità è la trascendenza del sacro.
1.2. La presenza di Cristo nella liturgia e la singolarità.
Nell’ambito del cristianesimo emerge con particolare forza la tensione tra il contesto che implica forme di classificazione e la singolarità che eccede rispetto a ogni classificazione. Il cristianesimo, indubbiamente, va costruendo contesti teorici e pratici entro cui collocare gli eventi della vita e così dare loro senso, ma la cosa fondamentale è che alle sue origini non sta in primo luogo un contesto regolato da norme e tanto meno un sistema teorico elaborato secondo concetti universali coerentemente disposti. All’origine del cristianesimo stanno alcuni eventi storici la cui valenza teologale è tutta nella singolarità di Gesù Cristo. Per il cristiano, il senso della vita non viene da un sistema teologico ma dalla singolarità di una persona . Il problema che rimane aperto è come sia possibile che la singolarità di una persona possa valere per sempre e per tutti. Se l’universalità del cristianesimo fosse affidata alla trasmissione del suo messaggio non vi sarebbero problemi, tranne quello di verificare la possibilità che ovunque sia accolto quel messaggio. Non è però il messaggio di Gesù Cristo a salvare ma la sua persona. Sulla base di questo assioma, fondamentale per la fede, l’universalità non coincide con la possibile trasmissione a tutti del vangelo ma con la possibile presenza sempre e ovunque di Gesù Cristo. Se però Gesù rimane semplicemente nella sua singolarità non è possibile l’estensione della sua presenza. Occorre allora un «contesto» del tutto peculiare che allo stesso tempo possa essere vissuto da qualsiasi generazione e mantenere la singolarità del Cristo: un contesto che non sia il luogo di trasmissione di un messaggio ma il luogo della presenza di Gesù Cristo nella sua singolarità. Sembra che tale contesto sia la liturgia.
Questa almeno è quanto emerge da Sacrosanctum Concilium là dove dice che «Cristo è sempre presente nella sua chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa sia nella persona del ministro […] sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti […]. È presente nella sua parola […]. È presente infine quando la chiesa prega e loda» (SC 7). Il testo si presta a diverse interpretazioni ma non si possono avere dubbi sul fatto che la presenza di Cristo implica la sua azione: è presente non perché se ne parta ma perché lui parla e agisce. Ma quale linguaggio consente di «percepire» Gesù non solo come colui di cui si parla ma anche come colui che parla, e quale azione consente di «percepire» Gesù non solo come colui di cui si ripetono i gesti ma come colui che compie i gesti? Non solo non basta dire qualcosa di Gesù, ma non basta neppure dire che nella liturgia è Gesù a parlare e agire. Occorre «percepire» tutto questo. In altri termini, la questione non è la «presenza di Cristo» ma l’«esperienza della presenza di Cristo». Dire il nome e vedere il volto riguardano questa sperienza.
2. Il NOME E IL VOLTO COME FORME DELLA SINGOLARITÀ.
La tesi che si intende sostenere è che il nome e il volto sono forme fondamentali della singolarità con la conseguenza che sono decisivi per la presenza di Cristo nella liturgia. Prima di affrontare la questione teologica, però, occorre individuare in che senso è da intendere lo stretto legame della singolarità col nome e col volto. A tal proposito è bene precisare subito che ci si intende riferire al nome proprio nella sua qualità specifica rispetto a qualsiasi altra componente del linguaggio verbale, e al volto come linguaggio iconico da intendere entro il quadro di riferimento della filosofia dell’altro.
2.1. La dinamica del nome: il sé.
La questione del nome coinvolge l’ambito linguistico e quindi quello del rapporto tra un significante e un significato. Come ogni segno, anche il nome è un significante il cui significato può essere decodificato grazie alla sua collocazione testuale e contestuale. Il problema è di sapere se nell’ambito religioso il significante sia riducibile al reperimento del significato o se implichi delle dinamiche del tutto peculiari. Prima di interrogare l’ambito religioso, però, è bene tenere presente lo specifico fenomeno del «nome proprio», che alla luce di una prima osservazione sembra evocare una realtà capace di rimanere identica a se stessa nel passaggio attraverso diverse situazioni spazio-temporali. L’Ulisse di Omero e l’Ulisse di Dante subiscono mutamenti semantici piuttosto profondi a causa dei diversi contesti letterari e culturali. Eppure l’intenzione è di riferirsi al medesimo personaggio, con la conseguenza che al cambiamento di situazione storico-culturale si sovrappone la continuità del nome. Quale rapporto semantico esiste tra il cambiamento di contesto e la continuità del nome? Quale rapporto esiste tra il modo di significare dei molteplici termini presenti in un contesto e il modo di significare del nome proprio?
Nell’affrontare questioni di questo tipo, o simili, C. Lévi-Strauss osserva: «Dire che un termine viene inteso come un nome proprio, equivale a dire che si pone a un livello oltre cui non è più necessaria nessuna classificazione, non in un senso assoluto, ma nell’ambito di un determinato sistema culturale. In ogni sistema, quindi, i nomi propri rappresentano dei quanta di significato al di sotto dei quali non si può fare altro che mostrare» . L’antropologo mette in evidenza che il nome proprio è legato al contesto, e più precisamente al sistema culturale, ma sottolinea che in tale sistema svolge un ruolo del tutto peculiare costituito dal salto dal rappresentare al mostrare. In ultima analisi, il nome proprio è ciò con cui designiamo degli individui, dei fenomeni contingenti che sono semplicemente identici a se stessi. L’argomento è stato trattato da S. Kripke in termini di logica del linguaggio. Secondo Kripke il nome con cui si designa un oggetto e, in particolare una persona, è cosa ben diversa dalla descrizione dell’oggetto o della persona. Il nome non indica la somma delle caratteristiche di una persona o l’insieme dei significati che si attribuiscono a un oggetto. Il nome indica una persona specifica che rimane tale anche se le sue caratteristiche cambiano o se i significati che le vengono attribuite subiscono delle modifiche. Il nome proprio sottrae l’individuo alla dipendenza dai significati. Se il linguaggio spesso è utilizzato per descrivere un determinato fenomeno o individuo, inglobandolo in un determinato ordine semantico, col nome proprio si ha un uso diverso del linguaggio, grazie al quale è possibile indicare un individuo anche se di lui si conosce pochissimo e se, col tempo, questa conoscenza si arricchisce notevolmente.
Il nome proprio non poggia su un processo di classificazione e di categorizzazione, secondo cui del singolo si predica qualche significato, ma sull’atto di relazionarsi al singolo nella sua singolarità indeducibile. J. Searle, pur discostandosi dalla tesi di Kripke, riconosce la peculiarità dei nomi propri, tanto rispetto agli enunciati descrittivi (es.: «Dante ha scritto la Divina commedia»), quanto rispetto ai dimostrativi (es.: «Questo è Dante»). «Diversamente dai dimostrativi – scrive Searle – i nomi propri si riferiscono [a qualche oggetto] senza presupporre un allestimento scenico o delle speciali condizioni contestuali attorno all’emissione dell’espressione. Diversamente dalle descrizioni definite, in generale essi non specificano alcuna caratteristica degli oggetti cui si riferiscono» . Anche se si deve riconoscere che i nomi propri coinvolgono, implicitamente, una qualche descrizione dell’oggetto in questione, «essi funzionano non come descrizioni, ma come ganci a cui appendere descrizioni» , poiché il loro interesse prevalente è referenziale e non descrittivo, denotativo e non connotativo. Se l’enunciato descrittivo è il linguaggio della conoscenza, il nome proprio è il linguaggio dell’incontro.
La questione può venire affrontata evocando il triangolo semiotico. Nella maggior parte dei casi noi ragioniamo secondo il modello triangolare: un determinato termine o significante rimanda a un dato concetto o significato; il significato, poi, rimanda a una realtà concreta o referente: il termina «cane» è un significante sonoro che risveglia in noi il concetto di cane ossia un determinato significato che si configura secondo diverse connotazioni, come per esempio quello di animale a quattro zampe; questo significato ha il suo referente nel cane in carne ed ossa che gioca nel giardino. Il nome proprio, pur coinvolgendo l’ordine dei significati, mostra una predilezione per il rapporto diretto tra il significante e il referente: il termine «Giorgio» è un significante sonoro che può indubbiamente avere un significato ricco di molteplici connotazioni, ma che per se stesso può esaurire il suo compito nel semplice rimando al suo referente che è Giorgio in carne ed ossa. Indubbiamente posso pensarlo «in carne ed ossa» e quindi attribuirgli dei contenuti semantici che però sono comuni a tanti altri esseri viventi. Col nome proprio opero un’epochè semantica per riferirmi a Giorgio nella sua unicità, e quindi oltre qualsiasi descrizione che lo assimila agli altri individui. Per questo motivo esso è più il linguaggio dell’incontro che della conoscenza della realtà. L’uomo ha riempito il mondo di significati rischiando di non incontrare più le cose del mondo nella loro unicità e irripetibilità. Il nome proprio ci mantiene nell’orizzonte dell’incontro in cui l’altro è veramente il trascendente, ossia ciò che trascende la cattura semantica. Il contesto, il gioco linguistico, è indispensabile per la comprensione corretta di un individuo; ma l’individuo è più della sua comprensione, trascende qualsiasi possibile contesto, proprio per quel nome che lo denota senza connotarlo.
Alla luce di quanto si è detto si apre una questione piuttosto importante a cui non ci si può sottrarre anche se qui verrà trattata solo per accenni. Intendo riferirmi alla relazione tra il nome proprio come espressione della singolarità e la dinamica parte-tutto. Questa dinamica e quindi quella relazione coinvolgono il tema della «complessità» . La riconduzione del singolo a un contesto e del nome a un sistema di significati risponde al criterio della complessità che intende la parte alla luce del tutto. L’attenzione alle specificità della singolarità e del nome proprio non invalida questo criterio ma lo sposta verso un’altra prospettiva in cui intendere la complessità. L’irriducibilità tassonomica del singolo e l’indeducibilità semantica del nome implicano una complessità non estensiva ma intensiva, ossia legata all’unicità indeducibile di un individuo. Prendiamo un esempio. Il signor A pensa nella sua mente il sistema galattico che rende possibile le stelle e i pianeti, oppure il sistema sociale che è alla base dei fenomeni economici di una nazione; in tal modo il signor A riconduce le parti (stelle, pianeti, fenomeni economici) al tutto (sistema galattico, sistema sociale). Ma il supporto di tali pensieri, ossia il signor A in carne ed ossa, è un tutto entro cui i sistemi galattico e sociale, in quanto pensati, sono una parte. Il signor A nella sua singolarità è più complesso della galassia e della società che lo steso signor A pensa e descrive. La misurazione dei livelli di complessità, quindi, varia a seconda dei punti di vista. In uno di tali punti di vista, la singolarità non è una parte ma un tutto. Ugualmente, il nome proprio, se sotto il profilo connotativo è una parte rispetto a un sistema di concetti, sotto il profilo denotativo è un tutto irriducibile al sistema di concetti e ciò grazie a cui è possibile l’elaborazione di qualsiasi sistema di concetti.
La complessità del singolo e la sua irriducibilità a un sistema di concetti è il sé nella sua irriducibilità tassonomica. Col nome proprio si pone in linguaggio il sé. L’unica logica di tale linguaggio è la tautologia: il sé è il sé, Giorgio è Giorgio. La tautologia, tanto sterile per i nomi comuni, è la massima fecondità del nome proprio, perché lo rende adeguato a esprimere il sé. «Io sono»: non sono qualcosa, non sono neppure un essere; «sono» e basta. L’imprendibilità del sé è il sé; l’indeducibilità del nome proprio è il nome proprio. In tal modo, il nome proprio dice il sé come ciò che non si può prendere e quindi non si può dire: il nome proprio dice l’indicibile. Ma perché «dice» se si tratta di dire l’indicibile? Perché il primo a dire il nome proprio non è chi lo porta ma un altro. Il nome proprio è il suono che viene dalla bocca di un altro, e anzitutto dalla bocca dei genitori. La parola che dice il sé nella sua irriducibilità, ossia che dice il sé in quanto sé, non è pronunciata anzitutto dal sé ma da altro da sé. Il nome proprio è un’espressione, e quindi fa uscire il sé da se stesso: lo fa uscire, però, non per pensare le cose ma per incontrare l’altro che per primo pronuncia il suo nome. Il nome proprio dice anzitutto che il sé ascolta e parla, ossia ricorre al linguaggio, per incontrare l’altro. Questo incontro viene a pienezza nel volto.
2.2. La dinamica del volto: l’altro.
La considerazione da cui prendere le mosse quando ci si riferisce al volto riguarda la vista, sia perché il volto è da vedere sia perché il volto vede. E cos’è intrinseco alla vista se non il gioco tra oscurità e luce, o meglio il modo con cui la luce vince l’oscurità rendendo possibile anche l’esperienza dell’oscurità? Occorre, però, precisare subito che l’oscurità non è vinta solo dalla luce ma anche da ciò che viene alla luce. Appartiene all’esperienza più diffusa che la luce non è solo ciò che illumina ma il modo con cui le cose si lasciano illuminare e di conseguenza come le cose illuminano chi le osserva. Qui è maestra l’arte e in primo luogo l’architettura. Come scrive E. Levinas, «l’arte dà alle cose come una facciata, grazie alla quale gli oggetti non sono soltanto visti, ma sono come degli oggetti che fanno mostra di sé. L’oscurità della materia rappresenterebbe appunto lo stato di un essere che non ha facciata. La nozione di facciata, presa a prestito dagli edifici, ci suggerisce che l’architettura è forse la prima della belle arti. Ma in essa si costituisce il bello la cui essenza è indifferenza, freddo splendore e silenzio» . Sebbene la «facciata» sia un importante superamento dell’oscurità, una luce già capace di orientare il cammino umano, è comunque accompagnata dalla percezione di una certa indifferenza. A dire il vero, l’offerta di una luce che squarcia l’oscurità della materia, non è mai indifferenza. Ciò che Levinas vuol sottolineare, però, è che vi sono altri livelli dell’esperienza che consentono di superare ben più radicalmente l’indifferenza, e più precisamente i livelli che muovono verso l’etica intesa come rapporto con l’altro.
L’indifferenza è il processo di assorbimento dell’altro nel medesimo, ossia in un io chiuso che finisce per omologare tutto ciò che esiste senza spazio per la differenza dell’altro. Nel passaggio all’etica, secondo Levinas, si supera l’indifferenza, dato che l’etica è il rapporto con l’altro sottratto a ogni violenta riduzione al medesimo, ossia è il rapporto con l’altro rispettato nella sua differenza. La precisazione da fare subito è che il rapporto con l’altro non è da intendersi come lo stare uno a fianco dell’altro , col rischio di ridurre tutto a una sorta di massa sociale. Il rapporto con l’altro supera l’indifferenza, ossia rende possibile il rispetto pieno della differenza, se lo si intende come lo stare faccia a faccia, dove il volto svolge un ruolo centrale. Il volto è l’epifania della differenza e, quindi, un aspetto fondamentale della singolarità intesa come vera trascendenza. Infatti, quanto vi è di più specificamente personale nel singolo individuo appare anzitutto nel suo volto che, in quanto volto dell’altro, diventa la principale cifra della sua differenza rispetto al medesimo e quindi la principale cifra della trascendenza. L’esperienza che facciamo quotidianamente è un gioco tra il senso del limite e l’incontro con l’altro. Da tale gioco emerge che l’esperienza rivela l’altro, e in quanto esperienza del limite rivela l’altro come ciò che è oltre il limite, ciò che trascende il limite . In questa prospettiva, il mondo non è più «natura» senza volto, ma «opera» dell’altro che si mostra come volto, come ciò che è visto e che vede, che si accorge d’esser visto. «Nel volto – scrive Levinas – quel che si esprime assiste all’espressione, esprime la sua stessa espressione, restando sempre padrone del senso che produce» ; guardando il volto di un altro io mi accorgo non solo di vedere, ma anche di esser visto, mi accorgo che chi mi sta di fronte è libero di venirmi incontro, così come è libero di sottrarsi a questo incontro; prendo coscienza di non poter ridurre l’altro a quella totalità in cui abitualmente raccolgo ciò che mi circonda, prendo coscienza dell’infinito oltre ogni totalità chiusa.
In questa prospettiva etica vi è molto di estetico, dato che l’apparire dell’altro nella sua differenza irriducibile e quindi dell’infinito rispetto alla totalità, è inscindibile dall’esperienza sensibile legata al volto. L’esperienza estetica non si lascia irretire in un pensiero che pretende di chiudere la realtà in una totalità concettualmente definita, e quindi favorisce l’apertura infinita che riconosce nel volto la trascendenza irriducibile dell’altro. Si può anzi fare una considerazione ancora più radicale: proprio perché primeggi la libertà dell’altro che mi viene incontro nel volto, deve essere posto in primo piano non il senso di responsabilità verso l’altro (che pure è di grande rilevanza) ma ciò che mi anticipa e che quindi anticipa anche il mio senso di responsabilità. Al primo posto è l’estetica del volto che mi consente di cogliere una profondità nuova dell’esperienza in cui non posso «conoscere», ossia possedere nella mia immanenza, ma solo «riconoscere», cioè accogliere nella sua trascendenza colui che mi ha preceduto rivelandosi.
3. LA PRESENZA DI CRISTO NEL NOME E NEL VOLTO.
La rilevanza del nome e del volto nei testi biblici è evidente: in entrambi i testamenti «dire il nome» e «vedere il volto» costituiscono aspetti centrali della fede. Ma che cos’hanno a che fare con la presenza di Cristo nella liturgia e col ruolo svolto da Maria? Si può rispondere orientativamente dicendo che il nome è la presenza di Cristo sotto il profilo del linguaggio verbale e che il volto è la presenza di Cristo sotto il profilo del linguaggio iconico. Il presupposto di questa risposta è che il linguaggio evoca una qualche forma di presenza che il nome e il volto elaborano secondo le loro caratteristiche.
3.1. Il nome come presenza di Cristo e sua relazione con Maria.
Il passaggio dal nome come linguaggio della singolarità al nome come linguaggio della presenza, e quindi della presenza di Cristo nella liturgia, rende inevitabile qualche osservazione sulla relazione tra linguaggio e presenza . La prima osservazione, abbastanza ovvia, è che il linguaggio evoca una qualche forma di presenza. Se dico «fuoco» avviene in me un fenomeno percettivo che accomuna il senso di una presenza e contemporaneamente l’avvertimento della sua assenza. Il fuoco non è lì, davanti ai miei occhi, ma il suono che lo rappresenta me lo evoca come se fosse lì. Occorre notare subito che dicendo «fuoco» ciò che, pur nella sua assenza, mi si rende presente non è il fuoco in genere ma una qualche immagine concreta, ossia quel dato fuoco. È pure vero, però, che la nostra mente fa anche un’altra operazione, ossia tende a riconoscere ciò che è comune a determinate realtà per distinguerle da altre, ossia procede classificando le cose. In altri termini, dire «fuoco» implica la dinamica presenza/assenza in un processo che muove dal concreto verso l’astratto.
La seconda osservazione riguarda la dinamica metaforico-simbolica del linguaggio, ossia il procedere verso una molteplicità di significati di un termine mantenendo il medesimo termine. La struttura essenziale del simbolo è risaputa: a partire dal medesimo significante, per esempio «fuoco», emerge un primo significato, che è quello della «combustione», e unitamente a questo un secondo significato, per esempio la «passione». Al moltiplicarsi e intrecciarsi dei significati corrisponde l’unicità del significante, con la conseguenza che nel simbolo il significante è una presenza inquietante, influente, coinvolgente. La questione è proprio quella della presenza. Quando «dire fuoco» implica l’intero impianto simbolico, allora il significante è preminente rispetto al significato. Ma mentre il significato è l’opera del rimando alla realtà, il significante è lì presente: l’atto di «dire fuoco» rimanda a qualcosa di assente, ma esso stesso è presente. Se il simbolo ha rapporti piuttosto complessi col sacro è anche per questa preminenza del significante, ossia del linguaggio come presenza e quindi della parola come presenza divina. Si pensi alla Sacra Scrittura che nella prassi ermeneutica della comunità cristiana feconda innumerevoli significati a partire dal medesimo significante biblico, solidamente presente nella comunità credente. Ciò implica che la Sacra Scrittura non è solo un testo che rimanda a una realtà assente, alla storia della salvezza, ma è essa stessa la presenza della realtà, la presenza della storia della salvezza.
La terza osservazione ci porta direttamente al nome. Quando il significante è un nome, un nome proprio, la dinamica simbolica riproduce una sorta di corto circuito. Come si è appena detto, il significante simbolico è preminente rispetto ai significati dato che li genera, ma quando si ha a che fare col nome proprio, che ha una valenza più denotativa che connotativa, allora si ha una sorta di ripiegamento del significante su se stesso che lo rende quasi indipendente dai significati. Il nome proprio è indubbiamente il soggetto a cui si possono attribuire molti predicati, ossia molti significati, ma per se stesso è indipendente dai predicati, dai significati. Qui il significante è la sua semplice presenza. Col nome proprio la dinamica simbolica mantiene il processo di rimando a più livelli di significato, ma, allo stesso tempo, implica il processo di rimando a se stesso come primo e fondamentale punto di partenza. Il nome proprio è il linguaggio che raggiunge il massimo della presenza perché è anzitutto tautologico: Gesù è Gesù. A partire dal nome proprio Gesù si possono elaborare un primo significato, per esempio il definirlo nazareno o figlio del falegname, e un secondo significato, per esempio il riconoscerlo come il Cristo o il Figlio di Dio. «Nazareno», «figlio del falegname», «Cristo», «Figlio di Dio» esprimono dei contenuti, dei significati, che si applicano alla singolarità racchiusa nel significante Gesù. Nella sua qualità di nome proprio, però, Gesù è anzitutto il significante che rimanda a se stesso: è presenza prima e al di là di ogni ulteriore definizione.
La forza simbolica del nome nella Bibbia è nota a tutti. Secondo l’ebraismo, il nome di Dio deve essere trattato con immensa cautela ed è tendenzialmente impronunciabile. Il nome di Dio, come il nome proprio, è semanticamente indeducibile e vale per la sua semplice presenza: il rispetto che si deve al nome di Dio è il rispetto che si deve a Dio. La fede cristiana mantiene questa cautela ma, allo stesso tempo, concentra l’attenzione sul nome che garantisce la possibilità di dire Dio e di ottenere la salvezza: «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati» (At 4,12). La rilevanza del nome «nel quale è stabilito che noi siamo salvati» deve venire compreso alla luce di quella trama fondamentale della storia della salvezza che è bene espressa dalle genealogie proposte dai racconti evangelici di Matteo e di Luca. Che si parta da Abramo, come fa Matteo, o che si risalga ad Adamo e infine a Dio stesso, come fa Luca, è fondamentale il nome entro la sequenza generazionale.
La storia della salvezza è una sequenza di nomi propri. Non vi è modo migliore per esprimere la natura della storia della salvezza che vive della continua tensione tra l’immagine che gli uomini si fanno di Dio e il Dio che incontra gli uomini. L’immagine che gli uomini e in particolare il popolo ebraico si fa di Dio è in evoluzione come mostrano le diverse teologie rintracciabili nei testi biblici. Si pensi soprattutto al passaggio dall’AT al NT e, tanto per segnalare gli estremi, tra un Dio che ordina di distruggere i nemici a un Dio che insegna ad amare i nemici. L’immagine di Dio cambia eppure si tratta sempre dello stesso Dio, come mostrano in modo estremamente lucido le genealogie presenti in Matteo e in Luca. Si tratta sempre del Dio che incontra Adamo, Abramo, Davide, fino a Giuseppe, Maria, Gesù. Il nome proprio ha un’etimologia che è rilevante nel contesto biblico e che dice qualcosa del personaggio: l’etimologia è la traduzione del nome proprio in nomi comuni. Anzi, il nome proprio è costruito come condensazione di nomi comuni che tendono a esprimere le caratteristiche della persona in questione. Non è questo, però, l’aspetto più importante. Come si è visto sopra, il nome proprio ha una funzione molto più profonda, che è quella di indicare un individuo nella sua unicità, tanto è vero che si ricorre ad altri nomi propri, ossia al nome del padre per precisare a chi ci si riferisce. Nella storia della salvezza questa peculiarità del nome proprio è fondamentale, perché costituisce la sua costante. E la costante consiste nel fatto che Dio incontra gli uomini nella loro concretezza e unicità, nonostante i diversi modi con i quali gli uomini si immaginano Dio. Se si parla di storia della salvezza e quindi di qualità «storica» della salvezza è anzitutto grazie alla concreta esistenza storica di coloro che rispondono al nome di Abramo, di Giacobbe, di Davide, di Giuseppe, di Maria, di Gesù. Alla luce di tutto questo si può affermare che la presenza di Cristo è nel nome di Gesù.
L’aspetto da non trascurare, è che i nomi propri sono legati dal processo della generazione: «Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda…» (Mt1,2); «Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi…» (Lc 3,23-24). La trama che lega l’intera storia della salvezza fatta di nomi propri è la sequenza generazionale e quindi la relazione tra padre/madre e figlio/figlia. Alla qualità storica della salvezza, espressa dai nomi propri, si aggiunge la sua qualità «biologica», espressa dalla sequenza generazionale. Si tratta di un aspetto che non può e non deve essere trascurato. La questione della vita e del suo rapporto dialettico con la morte costituiscono il fondamento ultimo di ogni religione e anche del cristianesimo che ha il suo centro nella pasqua di Cristo, ossia nella dialettica tra croce e risurrezione, tra morte e vita. Se esiste il cristianesimo è perché si nasce e si perisce, ossia perché la vita è continuamente messa in scacco dalla morte. E la prima espressione della vita è la generazione. La storia della salvezza è un fatto biologico, con la conseguenza che la presenza di Cristo, legata fondamentalmente al nome di Gesù, è strettamente connessa anche al fatto biologico col quale Gesù è stato generato. Non si tratta della banalità secondo la quale Cristo può essere presente solo a condizione di essere nato, ma del fatto che l’essere figlio costituisce la natura cristologica della storia della salvezza. La manifestazione di Dio in Gesù Cristo ha una mediazione intrinsecamente biologica, con la conseguenza che la rivelazione non è fatta in primo luogo di contenuti semantici comunicati da Dio all’uomo attraverso la parola, ma è fatta di eventi biologici a cui Dio decide di appartenere attraverso la sua parola che si fa carne. La presenza di Cristo ha quindi una qualità storica e una qualità biologica.
L’intreccio di questi due aspetti è la questione centrale della rivelazione. La centralità dei fatti biologici si incrocia con eventi storici che ne evidenziano la qualità teologale anche sconvolgendo i fatti biologici. Un momento rivelativo eccezionale per l’AT è il racconto del roveto ardente che accomuna un fatto biologico (la combustione di un roveto) con l’eccezionalità dell’evento (non si consuma). Nel NT il caso tipico di questo strano intreccio tra biologico e storico è rappresentato dalla vicenda di Maria di Nazaret. Se questa figura riceve trattamenti diversi e apparentemente contrastanti nel NT, dato che si alternano atteggiamenti di grande apprezzamento e di chiara relativizzazione , probabilmente è perché occorre mantenere l’intreccio tra i due aspetti, biologico e storico, mentre è da evitare la prevalenza di uno dei due. Se Maria è solo la madre fisica di Gesù, allora Gesù stesso può reagire chiedendo «chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» (Mt 12,48) e indicando i suoi discepoli come «mia madre e i miei fratelli» (Mt 12,49). Sarebbe inopportuno, però, sottovalutare l’aspetto fisico e biologico, perché Gesù non è solo colui che con la bocca annuncia la parola di Dio, ma prima di tutto è colui che con tutto il suo corpo è la parola di Dio: è quindi in un fatto squisitamente biologico, come la nascita di un corpo, che si concentra la parola di Dio e quindi la sua rivelazione. Questo fatto biologico, però, deve essere mantenuto nel suo stretto legame con l’unicità dell’evento storico che è sconcertante rispetto a qualsiasi fatto biologico. L’incrocio tra fatto biologico ed evento storico sconcertante è la condizione fondamentale della presenza di Cristo nel mondo. Ed è proprio in questo incrocio tra fatto biologico e evento storico sconcertante che consiste la peculiarità di Maria.
Tentiamo di considerare più attentamente il modo con cui Maria è l’incrocio tra fatto biologico ed evento storico sconcertante, prendendo in esame il racconto in cui Matteo narra gli eventi che preparano la nascita di Gesù. Anzitutto abbiamo l’inserimento di tale nascita nella sequenza generazionale: «Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo» (Mt 1,16). Poi si ha l’esposizione della perplessità di Giuseppe e dell’intervento dell’angelo di Dio: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,20-21). In modo inequivocabile, secondo il testo evangelico, Gesù è il figlio di Maria. Tutto corrisponde alla via biologica tipica della sequenza generazionale. D’altra parte c’è un’interruzione in tale sequenza: «Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù». Non si passa direttamente da Giuseppe a Gesù, ma si ha una deviazione che passa per una donna estranea alla linea generazionale. Si tratta di un evento storico che risulta sconcertante rispetto al fatto biologico e che intrecciandosi con quest’ultimo realizza la condizione fondamentale della presenza di Cristo nella sua peculiarità teologale.
Nessun concetto o parola o proposizione potrebbe tenere questa dinamica biologico-storico in una coerenza logica. Sono il nome di Gesù e il nome di Maria che tengono insieme, senza possibilità di una semantica coerente ed esaustiva, la tensione intrinseca al legame tra il dato biologico e l’eccentricità storica. Il nome proprio è la presenza di questa tensione che nessuna semantica potrebbe risolvere: il nome di Gesù, con cui si intreccia il nome di Maria, è la presenza del mistero divino, è la presenza di Cristo che è il mistero divino. Su questa via si può tenere che una donna sia allo stesso tempo vergine e madre, creatura e madre del suo creatore, e così via. Il nome è la presenza di ciò che sfugge alla delimitazione semantica, è la presenza del mistero divino che non è comprensibile all’uomo. La parola con cui Dio si rivolge all’uomo è anzitutto questo nome: la parola di Dio è il nome di Gesù. In ciò consiste la presenza di Cristo presso l’umanità.
3.2. Il volto come presenza di Cristo e sua relazione con Maria.
Il punto di partenza del paragrafo precedente è stato il passaggio dal nome come linguaggio della singolarità al nome come linguaggio della presenza. Occorre ora considerare il passaggio dal volto come espressione iconica della singolarità al volto come espressione iconica della presenza. Come si è tentato di mostrare che il nome di Gesù è la presenza di Cristo, così si deve tentare di mostrare che anche il volto di Gesù è la presenza di Cristo . E in primo luogo bisogna considerare il valore dell’immagine intesa come linguaggio visivo entro cui si elaborano una qualche conoscenza ed elaborazione di senso. Ma di che conoscenza si tratta? Non di quella elaborata dal linguaggio verbale attraverso il processo discorsivo che applica dei predicati a dei soggetti, ma di una conoscenza che affonda le sue radici in un modo prediscorsivo di conoscere il mondo . L’immagine è vedere il mondo con la forza percettiva di una presenza che anticipa la parola e che all’occorrenza può ben integrarsi con essa. Il punto nodale è costituito dalla relazione dell’immagine col vedere e dalla constatazione che la vista si esplica sempre nell’elaborazione di una qualche immagine. Per la vista la realtà è data sempre nell’immagine. Guardando l’albero che si trova nel giardino la vista elabora l’immagine dell’albero che non è mai l’albero stesso ma appunto una sua immagine. Sotto questo profilo, non vi è molta differenza dall’albero dipinto su un quadro, che è ugualmente un’immagine dell’albero. L’atto del vedere ha sempre a che fare con l’immagine, pittorica o meno che essa sia.
Le ricerche neuroscientifiche confermano che la visione è un processo attivo e non passivo, dato che il cervello di chi fa l’esperienza del vedere non si limita a organizzare i dati percepiti dall’occhio ma li condiziona contribuendo così all’identificazione di ciò che si vede ; l’artista, a sua volta, non si limita a copiare la realtà esterna, poiché anche nel caso dell’arte figurativa, e ancora più in quella astratta, tende a esprimere un aspetto dell’oggetto osservato. Da quanto si è detto sopra e dalle conferme neuroscientifiche si può comprendere che la presenza di qualcosa, essendo legata a un vedere che non è solo passivo ma anche attivo, non è riducibile a una discriminazione netta tra pittura e realtà: infatti, non solo nel caso del «vedere l’albero in un quadro» ma anche nel «vedere l’albero nel giardino» non ci si trova mai direttamente a contatto con la realtà ma sempre con una mediazione iconica della realtà (ossia con la dimensione attiva del vedere). E così coloro che hanno visto Gesù per le strade della Palestina hanno elaborato un’immagine di Gesù, che non è Gesù stesso nel senso che non è il rapporto immediato con Gesù. La presenza di Gesù è sempre mediata iconicamente.
Sulla base di questa peculiarità dell’immagine occorre fare una seconda osservazione che riguarda il valore intersoggettivo del guardare e che ci porta a sottolineare la rilevanza del volto. Stabilito che non vi è un rapporto immediato con la realtà e che non solo il «vedere l’albero in un quadro» e il «vedere Gesù in una pittura» ma anche il «vedere l’albero nel giardino» e il «vedere Gesù in Palestina» implicano una mediazione iconica, occorre tenere presente che tra i due atti del vedere ci sono delle differenze. E in primo luogo si deve tenere presente che a differenza dell’immagine dell’albero visto in giardino e dell’immagine di Gesù visto in Palestina, l’immagine dell’albero e l’immagine di Gesù dipinti portano in sé l’interpretazione del pittore e quindi un modo di vedere il mondo. La pittura non è solo qualcosa di visto ma anche qualcosa che vede, che interpreta, che interpella. Ma come si è detto sopra, anche il volto dell’altro viene percepito come attivo, ossia come qualcosa che interrompe il dominio dell’io che vede e che immette la percezione dell’io di essere visto. Levinas definiva questa dinamica in termini etici e si è già osservato che rimane sempre molto rilevante, come del resto lo stesso Levinas ricorda, l’aspetto estetico inteso come coinvolgimento della sensibilità. Ora possiamo sottolineare l’aspetto estetico sotto il profilo più specifico dell’arte, e in particolare dell’arte visiva che rappresenta il volto. In tale arte, infatti, si ha una sorta di concentrazione tra due dimensioni «attive» del volto: a) quella legata all’esperienza quotidiana in cui il volto è attivo nel senso che sono interpellato dell’altro, sono visto dall’altro; b) quella dell’esperienza artistica in cui il volto è attivo nel senso che sono interpellato dal volto dipinto in cui è consegnata l’interpretazione dell’artista, sono visto dall’artista. L’icona, in quanto immagine dipinta del volto, è una sorta di concentrazione di presenza dell’altro.
L’icona che rappresenta il volto di Gesù è questo incrocio della presenza: a) sono visto dal volto di Gesù come posso essere visto dal volto di qualsiasi uomo o donna; b) sono visto con la carica interpretativa dell’artista che porta con sé la fede secondo la quale Gesù è il Cristo. È assolutamente importante tenere insieme i due aspetti: a) la qualità «attiva» del volto, mutuata dall’esperienza universale del volto implica che vi sia un «agente» e quindi la percezione di una presenza: Gesù è presente; b) a tale qualità attiva si aggiunge un’altra qualità attiva che dipende dalla prima e che la arricchisce con l’interpretazione di fede del pittore: Gesù è presente in quanto Cristo. Dal suddetto incrocio emerge che l’icona non è solo la rappresentazione di Gesù Cristo ma la presenza di Gesù Cristo. La lunga tradizione iconografica della chiesa conferma queste osservazioni, soprattutto se si tiene presente quella coscienza molto diffusa presso i credenti secondo la quale alcune icone esercitano un potere e quindi presuppongono una presenza. Il volto qui assume un risvolto simbolico di ampio respiro dato che riguarda il dipinto del volto ma anche il dipinto come volto. L’intreccio di cui si è parlato e che implica l’esperienza della presenza di Gesù Cristo, si può estendere oltre i limiti di un dipinto del volto e può riguardare ogni dipinto che si fa volto.
La presenza di Cristo consiste in un vedere il volto che diventa essere visti dal volto. In questa dinamica l’aspetto strettamente religioso è fortemente connesso al contenuto iconico, ossia all’intenzione di riferirsi a Gesù e alla sua qualità teologale. Ci si può chiedere se vi sia anche una aspetto formale, ossia un modo di realizzare l’arte visiva che favorisce l’esperienza religiosa entro cui può collocarsi più adeguatamente la fede nella presenza di Cristo. Un tentativo di risposta può avvalersi delle ricerche di G. Didi-Huberman. Questo studioso osserva come la tradizione cristiana, fondandosi sul mistero dell’incarnazione secondo cui Dio si manifesta nel corpo, è caratterizzata dal continuo confronto col corpo e della sua relazione con lo spirito. Fin dall’antichità l’incarnazione veniva «considerata un mistero sia del corpo che dello spirito: è dunque evidente che abbia ossessionato le raffigurazioni del cristianesimo, che sono quasi sempre rappresentazioni corporee. Ma allora, com’è possibile affrontare pittoricamente la differenza che separa un corpo qualunque, non misterioso, da un corpo che detiene o sostiene il mistero? Come interpretare quell’alito di estraneità che pervade i corpi dipinti del cristianesimo in Occidente? L’ipotesi fondamentale di questo libro – continua Didi-Huberman – è che la dissomiglianza può costituire il mezzo privilegiato di una tale “misterizzazione” dei corpi» . Un caso tipico di questa operazione si può riscontrare nel Beato Angelico e in modo particolare nei dipinti che si trovano nel convento di San Marco a Firenze. Lungo il corridoio centrale di tale convento a un certo punto si trovano delle vaste macchie multicolori, ossia qualcosa di sconcertante per come ci si immagina l’arte del quattrocento. Secondo Didi-Huberman, questa dissomiglianza è connessa a un’intenzionalità religiosa. Infatti, la semplice riproduzione realistica, ossia la somiglianza tra ciò che viene rappresentato e la sua rappresentazione, non consente all’immagine di superare la semplice materialità, mentre la voluta dissomiglianza rispetto alla pura imitazione realistica costituisce un dispositivo molto importante per aprire alla sfera spirituale.
La dissomiglianza è riscontrabile anche nelle icone orientali che riproducono i volti di Gesù, di Maria e dei santi. A tal proposito si può evocare la famosa teoria di P. Florenskij che nella scelta degli iconografi di rinunciare alla regole più ovvie della prospettiva vede una «dissomiglianza» molto importante per vivere il mistero cristiano nell’immagine . La questione che qui vorrei sottolineare, però, è un’altra. Si tratta di una questione molto delicata che riguarda l’immagine di Maria in relazione alla presenza di Cristo. L’icona di Gesù, ossia il dipinto del volto di Gesù, riguarda la presenza di Gesù. Allo stesso modo, sembra doversi dire che l’icona di Maria, ossia il dipinto del volto di Maria, riguardi la presenza di Maria. E invece avviene qualcosa di strano, dato che lo studio estetico-teologico delle icone e di altri dipinti mette in evidenza come le direttrici interne a tante opere implicano una sorta di indipendenza di Gesù (assolutezza di Gesù) rispetto a Maria a fronte di una dipendenza di Maria (relatività di Maria) rispetto a Gesù.
Si prenda la Pala di Brera, opera di Piero della Francesca. In tale dipinto si possono riscontrare diverse «difficoltà» per una concezione mimetico-realistica. Una delle più significative riguarda il rapporto tra Gesù bambino e la madre Maria. Il bambino è sulle ginocchia della madre in una posizione tale che dovrebbe scivolare per terra. Il volto e l’intero atteggiamento di Maria è allo stesso tempo profondamente orante e non curante del rischio che, realisticamente, corre il figlio. Se il dipinto non è da intendere come un’istantanea che precede il tragico evento della caduta, ma l’espressione di una condizione particolare dei personaggi, bisogna concludere che Gesù rimane saldo nella sua posizione senza scivolare non perché sostenuto dalla madre ma per una forza che lo rende indipendente da Maria e quindi dai condizionamenti fisici. L’atteggiamento di Maria, a sua volta, non è quello di una madre preoccupata che il figlio cada, con la conseguenza che viene riconosciuta l’indipendenza e per così dire l’assolutezza di Gesù. In altri termini, il volto e l’atteggiamento di Maria non dicono in primo luogo la presenza della madre di Gesù ma la presenza di quell’assoluta singolarità di Gesù secondo cui Gesù è il Cristo.
I dispositivi estetici caratterizzati dalla dissomiglianza possono riscontrarsi anche in dipinti che rappresentano personaggi diversi dalla Madonna. Nel caso di Maria, però, vi sono dinamiche peculiari rispetto ai santi. Maria, infatti, è la madre di Gesù, ossia la figura che ha dato la vita a Gesù e che quindi, più di chiunque altro, ne costituisce l’origine. La questione allora è: chi fa vivere chi, ossia chi è la vera origine della vita. La dissomiglianza produce un capovolgimento madre-figlio: la madre che dà la vita al figlio diventa il figlio che dà la vita alla madre. Se quanto si è detto sopra è vero, allora il volto di Maria non è Maria che mi guarda, ma è Gesù che, nonostante sia solo un bambino, mi guarda attraverso il volto di Maria. Nella dissomiglianza del dipinto di Piero della Francesca, Gesù è antecedente i condizionamenti fisici e quindi a Maria stessa. La madre non sostiene il figlio, ma è il figlio che sostiene la madre: per questo la madre non è preoccupata del figlio che può cadere ma è tutta concentrata nella preghiera.
3.3. Il rito come nome e volto della presenza di Cristo.
Ho cercato di mostrare che il nome e il volto sono linguaggi della presenza di Cristo e che Maria è parte integrante di tali linguaggi. Bisogna riconoscere, però, che il tema della presenza deve affrontare un interrogativo decisivo: presenza «dove»? Si è detto sopra che i nomi e i volti sono legati alla singolarità perché mantengono la loro pregnanza nonostante il cambiamento di contesti. Bisogna precisare, però, che la singolarità non si sostiene in assoluto né il nome e il volto sono in assoluto presenza, se per assoluto si intende qualcosa di oggettivamente necessario. Il nome e il volto sono espressioni della singolarità ed esperienza della presenza, ossia indipendenti dai molteplici contesti in cui possono venire riscontrati, a condizione che si realizzi il «contesto» del tutto particolare che sostiene le espressioni della singolarità e l’esperienza della presenza. Ciò presuppone che vi siano «contesti» che possono favorire la singolarità, il nome e il volto, in modo che essi siano vissuti come forme capaci di attraversare diversi contesti. Uno di quei «contesti» per così dire transcontestuali è il rito.
L’interesse per il rito è riscontrabile in uno degli autori a cui si è fatto riferimento in relazione al volto, ossia in Levinas. Concludendo le riflessioni sul volto si è tentato di recuperare l’esperienza estetica in riferimento all’accoglienza dell’altro nella sua trascendenza irriducibile e anticipatrice. In tutto questo si può scorgere qualcosa di molto familiare all’esperienza del sacro, ossia «del trascendente e dell’ineffabile» , ma soprattutto qualcosa di attinente alla modalità rituale di vivere il sacro. Levinas, nonostante alcune riserve sul sacro, riconosce l’importanza di quel dispositivo fondamentale del sacro che è il rito, e lo riconosce per quel duplice aspetto che coniuga la relazione agli altri e la relazione a Dio. Dal commento a un testo talmudico concernente la colpa e il perdono, Levinas deduce che «nel più rigido isolamento, ottengo il perdono. Ma allora si spiega perché, per averlo, ci voglia Jom Kippùr: come si può pretendere che una coscienza morale lesa nelle midolla trovi in se stessa l’appoggio necessario a intraprendere il faticoso cammino verso la propria interiorità e verso la solitudine? Per ottenere l’intimità della liberazione, bisogna ricorrere all’ordine oggettivo della comunità. Ci vuole un giorno fisso del calendario e tutto il cerimoniale della solennità del kippùr, perché la coscienza morale “danneggiata” possa raggiungere l’intimità e riconquistare l’integrità che nessuno può riconquistar per lei. Un’opera equivalente al perdono di Dio. Questa dialettica del collettivo e dell’intimo ci sembra della massima importanza» . In questa dialettica risiede l’importanza del rito per l’ebraismo. Ma l’intervento del rito, sebbene letto in termini etici, è più di un’etica che parte dalle scelte dell’individuo, dato che prevede quel «sacro» che per definizione anticipa le scelte dell’individuo. Il modello è etico, perché ha la forma del rapporto intersoggettivo, ma il fondamento è in qualche modo pre-etico perché quel rapporto non dipende solo dalla responsabilità dell’uomo. Siamo nella dinamica tipica del sacro nel suo senso più profondo: l’esperienza religiosa, che in quanto è la mia esperienza è ancora legata all’immanenza, ma, al tempo stesso, in quanto vive il limite inviolabile, appunto sacro, dell’altro, apre alla trascendenza .
La rilevanza del rito per le religioni in ordine al sacro e per l’ebraismo in ordine al rapporto con Dio si può riscontrare anche nel cristianesimo e in primo luogo proprio in ordine alla presenza di Cristo. Come si è accennato sopra, la presenza di Cristo nella sua singolarità è riconoscibile nella liturgia, ossia in un contesto rituale. Ora occorre tornare a considerare tale contesto in connessione alle tematiche del nome e del volto. La prassi ecclesiale testimonia ampiamente che il nome e il volto, nella loro qualità sacra, sono stati per lo più contestualizzati nella liturgia. Non a caso i riti cristiani si aprono con: «Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». La frase «nel nome» attraversa la liturgia nei suoi punti più rilevanti. A nessuno sfugge che qui «dire il nome» è riconoscere la presenza. Allo stesso modo, soprattutto a partire dalle icone orientali, «vedere il volto» è un atto di preghiera che prima di tutto riguarda il culto liturgico. Nella prassi ecclesiale sembra conservarsi la coscienza profonda che il nome e il volto trovano nel rito il conteso che ne salvaguarda il valore religioso, ossia l’esperienza della presenza di Dio. La tesi è appunto questa: il rito consente al nome e al volto, al dire il nome e al vedere il volto, di non venire banalizzati ma di mantenere la loro qualità di presenza del mistero divino. Vorrei segnalare alcuni fattori che consentono al rito di svolgere questo ruolo: si tratta dei fattori che da tanta letteratura antropologica vengono riconosciuti come aspetti fondamentali dei riti religiosi.
Un fattore decisivo è quello della liminalità che sta sempre più assurgendo a vero e proprio paradigma fondamentale dell’esperienza religiosa e anche a nuovo paradigma per interpretare i recenti eventi massmediali della cultura . Il transito delle esperienza sulla base dell’interruzione costituisce un punto nodale del vissuto umano riscontrabile nelle diverse culture ed epoche. Quel transito costituisce un punto decisivo nell’ambito delle religioni dato che la prima modalità con cui si presenta il sacro delle religioni, il santo biblico e l’esperienza della presenza di Cristo è costituita dall’interruzione rispetto a ciò che cade sotto i sensi e che è a disposizione del potere umano. Il rito è l’azione che, più di ogni altro aspetto delle religioni, gioca la carta della liminalità, e proprio per questo apre le porte alla sfera del sacro e del mistero. Si può leggere la liminalità anche alla luce di quanto si è detto sulla dissomiglianza. Infatti, essa è il fattore grazie al quale il rito interrompe la somiglianza con la realtà: il rito opera sul piano della dissomiglianza e così favorisce quella strategia estetica che assimila l’immagine al mistero, il volto alla presenza di Cristo. Ma mentre nel caso dell’arte visiva, la dissomiglianza gioca solo su alcuni piani espressivi, nel caso del rito si ha un impegno più ampio della dissomiglianza, dato che investe tutti i piani espressivi che ne fanno parte, compreso il linguaggio verbale e il nome.
Un altro fattore importante è quello della ripetizione che contribuisce a percepire gli oggetti come reali, e soprattutto a riconoscere la relazione simbolica tra i segni e gli oggetti. Com’è stato opportunamente osservato, per tale riconoscimento è indispensabile il rito, ossia la ripetizione di azioni che accostano segni e oggetti in un processo che apre a livelli sempre più complessi e astratti . Così, se la somiglianza tra il disegno di un cane e il cane rende intuitivo che il primo sia (o possa essere) segno del secondo, la dissomiglianza tra il termine cane (o dog) e il cane rende difficile riconoscere che il primo sia segno del secondo. La dissomiglianza rende controintuitivo il linguaggio verbale, ossia il rapporto tra la parola e ciò a cui rimanda la parola. In questo caso risulta quanto mai decisivo quel dispositivo rituale che è la ripetizione, dato che il ripetuto accostamento tra il termine cane (o dog) e il cane consente a un italiano (o a un inglese) di assimilare il rapporto simbolico tra i due. In altri termini, i simboli accostano segni e oggetti consentendo di superare i livelli fisici della realtà (la fisicità degli oggetti) per aprirsi ai livelli superiori (la simbolicità degli oggetti); ma poiché i simboli riescono in tale operazione perché sono ripetuti in azioni rituali, si può dire che le attività rituali aprono al «“significato superiore” di ciò che altrimenti è terreno» . È quanto avviene nel mondo delle religioni e nella stessa tradizione cristiana. La dissomiglianza su cui si fonda il sacro delle religioni e soprattutto l’esperienza della presenza di Cristo, interrompendo l’esperienza quotidiana che ci abitua a un certo modo di vivere la realtà, sembrerebbe rendere piuttosto irreale il sacro e la presenza di Cristo. Il rito ovvia a tale rischio grazie appunto al dispositivo della ripetizione, in modo che il sacro sia percepito come reale e che il Cristo sia percepito come realmente presente. La tesi che si intende sostenere è dunque la seguente: la dissomiglianza intrecciata con la ripetizione rafforza l’esperienza della presenza di Cristo nella liturgia grazie a quel contesto rituale che assomma il reale (presenza reale) allo straorinario (presenza della realtà divina).
Esiste un altro fattore da non trascurare, ossia quello della sinestesia che consiste nell’intreccio di diversi ambiti della percezione sensibile: visiva, sonora, spaziale e così via . La questione che qui interessa è la mediazione linguistica e artistica della sinestesia, ossia il coinvolgimento dei diversi tipi di sensibilità umana attraverso l’attivazione di una pluralità di linguaggi e di arti. Il rito è il contesto in cui si ha non solo l’attivazione di molteplici linguaggi ma anche il loro intreccio in un programma coerente. Il rito è un contesto sinestetico e multimediale nel quale nome e volto si possono incrociare in modo da influenzarsi e rafforzarsi reciprocamente. Ma se dire il nome proprio e vedere il volto dell’altro, come si è tentato di dimostrare sopra, sono dispositivi della presenza di Cristo, il loro intreccio rituale nella liturgia intensifica l’esperienza della presenza di Cristo. A tale considerazione, se ne dovrebbe aggiungere un’altra che riguarda un sorta di capovolgimento della presenza. L’attivazione di molteplici linguaggi ha un effetto che è stato particolarmente sfruttato nella realtà virtuale, perché tende a far sentire la persona «nella» e non solo «di fronte alla realtà». Il rito religioso tende a fare stare nel sacro e il rito cristiano tende a fare stare nel mistero divino. In altri termini, la sinestesia e la sua mediazione multilinguistica, tendono a rendere il credente presente nel mistero celebrato. E così il nome e il volto non sono solo la presenza di Cristo nella liturgia ma anche la presenza liturgica del credente in Cristo.
Prof. Giorgio Bonaccorso, monaco benedettino,
docente presso l’Istituto di Liturgia Pastorale
di Santa Giustina (Padova)