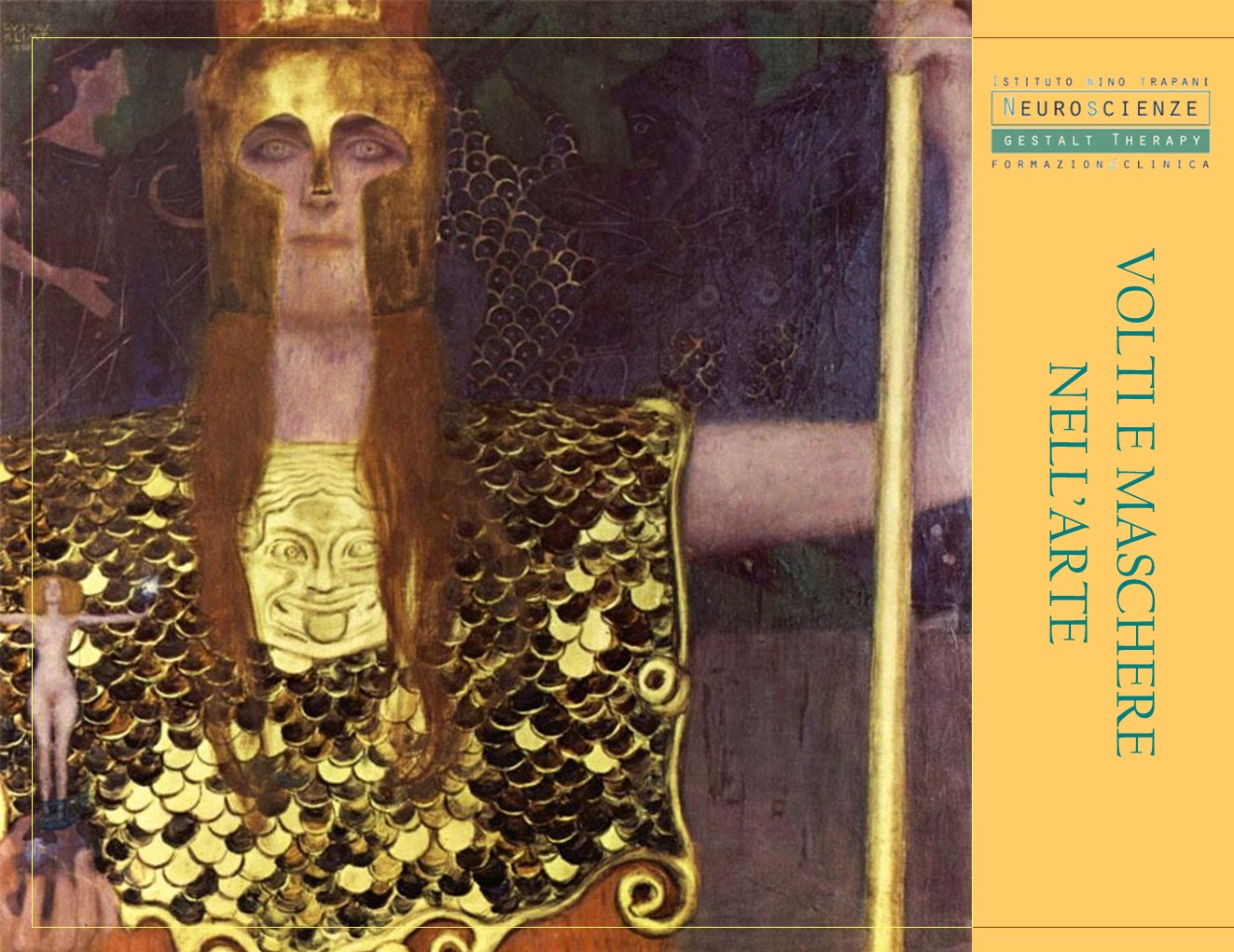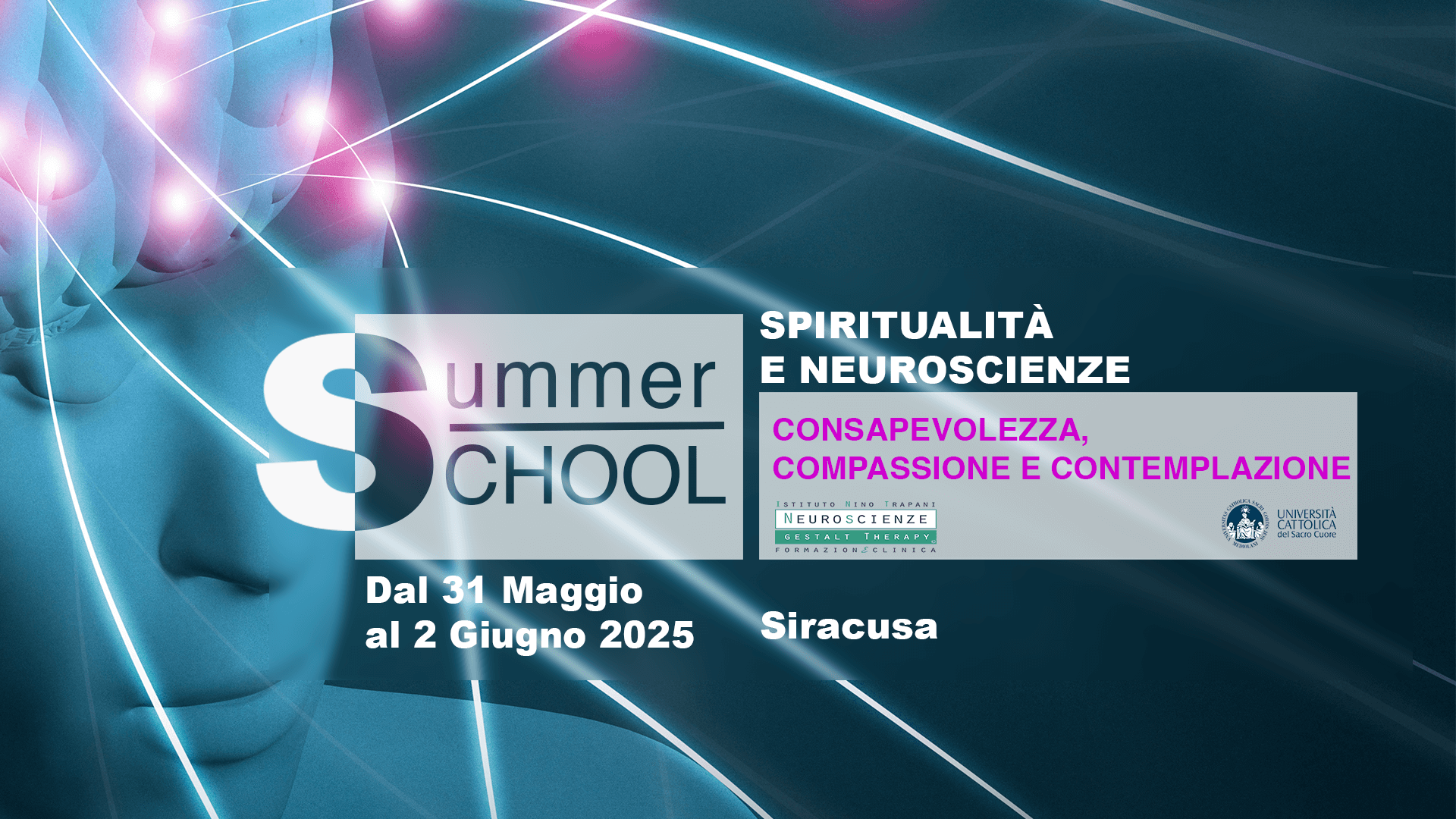Dietro le Maschere
Con un unico termine, πρόσωπον (prosopon), il greco antico indicava sia il volto che la maschera, come a dire che non esiste una dicotomia tra le due parole ma l’uno fluisce nell’altra. In ambito teatrale gli attori greci (esclusivamente maschi) indossavano la maschera per esprimere sentimenti ed emozioni sulla scena e dare identità visibile al personaggio, permettendo al pubblico di distinguerlo e riconoscerlo anche a distanza. L’uso della maschera, inoltre, consentiva agli attori di interpretare nella stessa recita più ruoli, compresi quelli femminili, ma soprattutto di dare volto e voce agli dei, che per definizione non potevano avere un volto umano. Nella sua opera omnia Le maschere di Dio Joseph Campbell (1904-1987), uno dei massimi esperti mondiali di mitologia, ripercorre la storia dell’uomo, delle sue radici, dell’origine del pensiero, dell’arte e della religione, a partire dalla mitologia primitiva attraversando quella orientale e occidentale per arrivare alle mitologie creative dell’era moderna. Un’affascinante e sistematica comparazione di simboli, miti, riti, racconti, teogonie che mira a confermare e avvalora la tesi dell’unità evolutiva della specie umana, non soltanto nella sua storia biologica, ma anche in quella spirituale. Secondo Campbell, infatti, il luogo mitogenetico originario è la mente umana, creatrice e distruttrice di tutti gli dei, capace di dare vita a immagini poetiche per entrare in relazione con il sovrannaturale ed esprimere il senso del numinoso, insito nel cuore dell’uomo. Gli studi neuroscientifici, in particolare quelli sull’effetto placebo e sull’effetto nocebo, confermano quanto intuito da Campebell e fanno affermare a Fabrizio Benedetti, neurofisiologo di fama mondiale, che la Speranza è un farmaco. Nel suo libro Benedetti spiega come all’interno della relazione di cura, tra il curante e il curato, si instauri un legame basato sulla fiducia e sulla speranza della guarigione, capace di attivare circuiti e reti neurali, sviluppatesi nel corso della filogenesi, in grado di modulare il nostro sistema immunitario ed endocrino e produrre sostanze che agevolano o ostacolano la guarigione. In fondo se per migliaia di anni, in assenza di farmaci potenti come quelli disponibili ai giorni nostri, lo sciamano con le sue maschere e i suoi riti riusciva a curare e in alcuni casi anche a guarire, lo si deve proprio a questi meccanismi biochimici che si innescano nella relazione di cura. Anche oggi accade. Indossare un camice bianco o una tuta operatoria verde, incontrarsi in un setting terapeutico è ripetere un antico rituale, il nostro modo di “mascherarci” per confinare e rendere manifesto il nostro ruolo all’interno del processo di cura (Funzione personalità del Sé diremmo in Gestalt Therapy). La maschera (prosopon), dunque, non per occultare o peggio mistificare il Sé ma strumento di identità relazionale per incontrare l’altro con responsabilità e chiarezza.
Viene spontaneo concludere che l’Umanità da sempre indossa le maschere per raccontare storie, per ricordare eventi vissuti, per dare un’identità all’Ineffabile, per prendersi cura dell’altro, per esprimere la creatività e tramandare la vita.
Rita Garofalo
Psicoterapeuta didatta Master PNEI e Neuroscienze
Istituto Nino Trapani e Università Cattolica S.C.